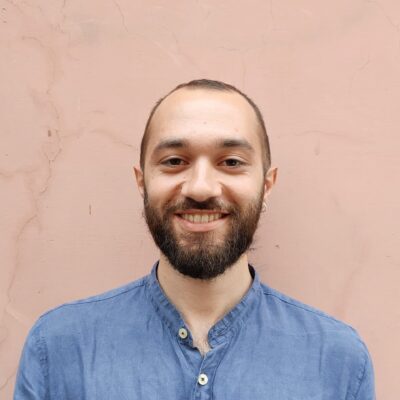Articolo inserito nell’ambito della rubrica Algo-cracy
a cura dei ricercatori Jacopo Caja e Jacopo Tramontano
Algoritmo: alleato o nemico?
Il dibattito sui processi di digitalizzazione e di piattaformizzazione del lavoro ha eletto gli algoritmi a nemico giurato. Gli algoritmi sono processi logico-matematici, codificati nel linguaggio informatico, che irregimentano le piattaforme digitali e, in misura crescente, anche altre organizzazioni operanti in settori tradizionali. Tecnicamente, ciò che gli algoritmi fanno è processare una serie di dati in ingresso – input – per prendere decisioni – output: come ordinare il feed di un account Instagram, a quale fattorino assegnare la consegna di una pizza a domicilio, se accordare o meno il diritto ad un sussidio statale. Non sono tecniche nuove, né è nuovo il fatto che gli algoritmi equipaggino delle macchine.
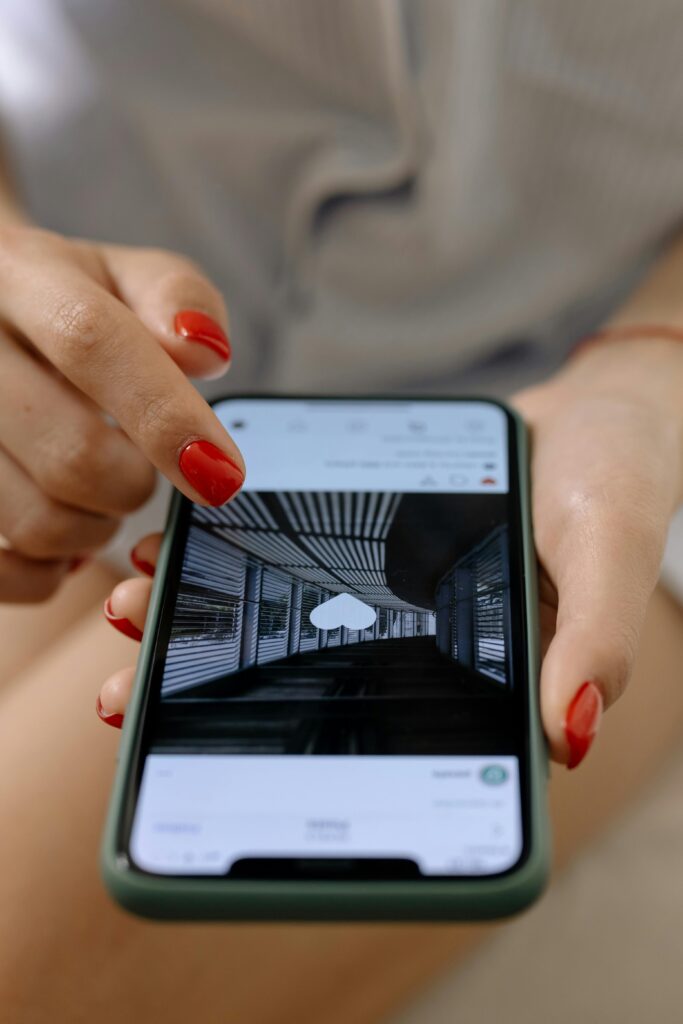
Ciò che è radicalmente inedito, negli algoritmi odierni, è la capacità crescente di auto-apprendimento, la mole di dati che hanno a disposizione e il fatto che tali dati vengono prodotti in tempo reale da utenti dispersi nello spazio e nel tempo. Per via di queste novità, la penetrazione dei sistemi algoritmici nel mondo del lavoro è salutata con entusiasmo da chi la considera come un volano di efficienza dei processi produttivi, ma genera timori per le sue conseguenze sul lavoro. In primis, riguardo la possibilità che attivino processi di sostituzione del lavoro senza precedenti. In secondo luogo, per le capacità di sorveglianza e controllo del lavoro che porterebbero in nuce.
Sono preoccupazioni molto fondate, come dimostrano le cronache quotidiane sulle condizioni di precarietà dei lavoratori della gig economy, che tuttavia rischiano di mirare il bersaglio sbagliato. In generale, il modo in cui siamo soliti articolare i nostri ragionamenti sugli algoritmi – sia in un’accezione positiva che negativa – poggia su un pensiero deterministico sulla tecnologia. Ovvero, su due presupposti: 1) lo sviluppo tecno-scientifico segue una logica autonoma dai processi socioeconomici ed istituzionali; 2) una volta realizzate e messe in circolo, le tecnologie producono degli impatti direttamente osservabili e analiticamente isolabili sulla società. Questo immaginario deterministico diventa particolarmente visibile se proviamo a decostruire tre grandi narrazioni sulla digitalizzazione.

“This time it’s different”
Ovvero, l’idea di trovarci di fronte ad uno sviluppo tecnologico di portata epocale, che modificherà radicalmente le modalità di organizzare la produzione e favorirà tassi crescenti di automazione. Profezie come questa si sono presentate ciclicamente nel corso della storia, molto spesso in corrispondenza di grandi crisi socioeconomiche. Già Keynes, durante la Grande Depressione, ravvisava le condizioni di una preoccupante “disoccupazione tecnologica” dovuta all’introduzione massiccia dei trattori nella produzione agricola. D’altro canto, l’innovazione tecnologica è da sempre alla base degli sforzi di razionalizzazione produttiva che guidano le dinamiche estrattive del capitalismo.
La digitalizzazione non segue una traiettoria di sviluppo autonoma, né produce un impatto isolabile sulla società, ma prende forma in seno ad un dato contesto sociale, economico ed organizzativo, che a sua volta contribuisce ad influenzare.
La ricerca empirica realizzata finora ci informa, tuttavia, che un’automazione piena non è neppure all’orizzonte. Uno studio comparativo sull’impatto di algoritmi e robotica nell’industria dei servizi, realizzato lo scorso anno dal Joint Research Centre, evidenzia che l’automazione risulta particolarmente difficile da realizzare nel caso di mansioni a basso valore aggiunto e per le attività che richiedono una riconfigurazione di compiti fisici, con la probabile conseguenza di aumentare – piuttosto che contrarre – la domanda di lavoro scarsamente qualificato e retribuito. Inoltre, laddove si realizza più compiutamente, l’automazione non sembra produrre un impatto significativo in termini di sostituzione del lavoro, ma più complesse riconfigurazioni organizzative. Queste sono spesso accompagnate dalla necessità di ripensare spazi e tempi del lavoro, dalla nascita di nuovi ruoli e relazioni professionali, dalla richiesta di competenze diverse.

Manodopera e automazione
Nel tentativo di articolare meglio il dibattito sulle conseguenze della digitalizzazione, gli studiosi delle organizzazioni preferiscono utilizzare i concetti di “automazione limitata” e di “automazione mista”. Il primo tiene in considerazione tutti i fattori sociali, economici ed organizzativi che possono limitare i processi di automazione. Ad esempio, la presenza di manodopera a basso costo, facilitata dall’esistenza di catene del valore globali e dalla flessibilizzazione del mercato del lavoro, rende sconveniente, per molte aziende, investire copiosamente in automazione. Il concetto di automazione mista, invece, evidenzia che l’automazione è sempre accompagnata da una dose di lavoro svolto da umani. Ad esempio, per gestire casi particolarmente complessi o per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Si parla in tal senso di “lavoro invisibile” per riferirsi a tutto quell’insieme di attività più o meno routinarie necessarie a far sì che algoritmi e macchine intelligenti funzionino concretamente – ad esempio, l’attività dei moderatori di contenuti che giudicano se una foto su Facebook rispetti le condizioni d’utilizzo della piattaforma. Nel suo “Schiavi del clic”, Antonio Casilli ha ben documentato il carattere “misto” e “limitato” dei processi di automazione, scoprendo una scatola nera fatta di micro-lavoro svolto da una classe di lavoratori sottopagata e in gran parte dispersa nel Sud globale, ma anche dall’attività degli utenti online che quotidianamente allenano la cosiddetta intelligenza artificiale. I concetti di automazione limitata, automazione mista, lavoro (reso) invisibile dall’automazione dovrebbero dunque ricordarci che la digitalizzazione non segue una traiettoria di sviluppo autonoma, né produce un impatto isolabile sulla società, ma prende forma in seno ad un dato contesto sociale, economico ed organizzativo, che a sua volta contribuisce ad influenzare. Ciò dovrebbe anche persuaderci a dedicare meno energie ad immaginare un futuro del lavoro senza lavoratori, ma a concentrarci su come oggi stiamo organizzando il lavoro che servirebbe, secondo i migliori auspici, a realizzare un simile scenario futuro.
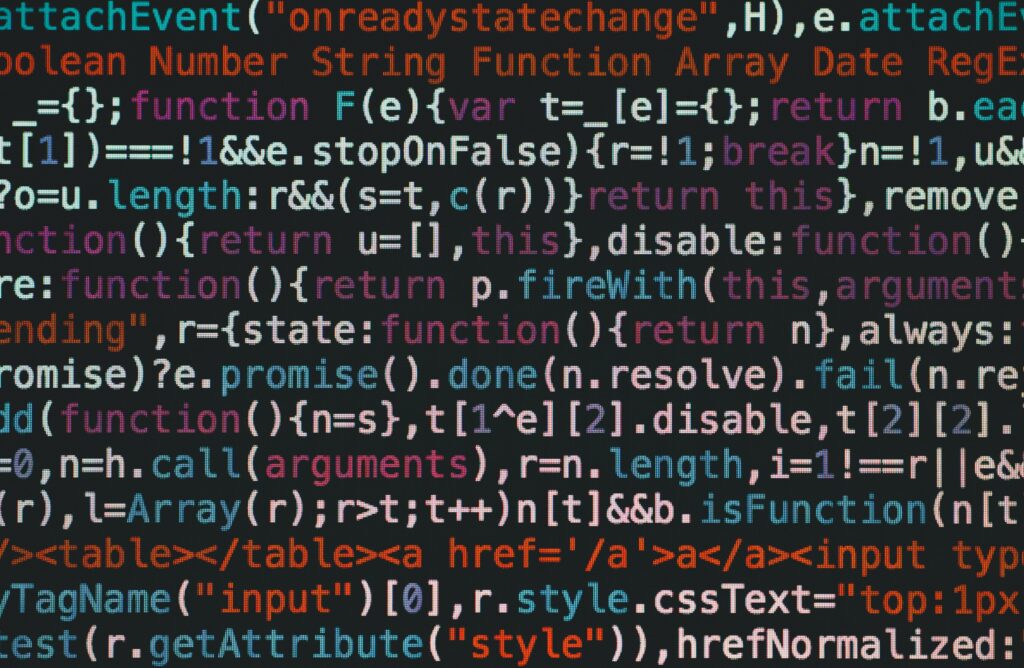
“Il tuo capo è la tecnologia”
Per le ragioni di cui sopra, dovremmo anche cercare di non confondere i processi di digitalizzazione con le infrastrutturetecnologiche che vi sono alla base. Il lessico della digitalizzazione, infatti, è saturo di espressioni che utilizzano il termine algoritmo come una sineddoche di sistemi socio-organizzativi molto più complessi. Si parla di algorithmic boss, di lavoro algoritmico, di governance algoritmica. Sono evidentemente semplificazioni linguistiche, che però rischiano di essere fuorvianti. Da un punto di vista squisitamente tecnico, come notavamo poco fa, per prendere decisioni gli algoritmi necessitano di standard, strutture di dati, software, dispositivi più o meno complessi. Si pensi, ad esempio, all’importanza dei sistemi di tracciamento geolocativo presenti all’interno dei nostri smartphone – i GPS – senza i quali piattaforme come Deliveroo o Uber non potrebbero funzionare. Oppure, al ruolo dei sensori e dei dispositivi indossabili impiegati all’interno di molti centri logistici, come quelli di Amazon. Quando parliamo di management algoritmico, insomma, ci riferiamo implicitamente all’azione collettiva di un insieme incredibilmente complesso di tecnologie, che definire algoritmi è riduttivo – ma efficace a catturare interessi e critiche.
[Dobbiamo] prendere sul serio l’idea che non siano gli algoritmi a produrre effetti sul lavoro, ma è il modo in cui entrano in relazione con particolari condizioni di lavoro e strutture di potere a trasformare il nostro modo di lavorare.
Rompere la “black box”?
Soprattutto, qualificare un particolare regime manageriale come “algoritmico” rischia di mettere in secondo piano l’esistenza di tutta una serie di altri dispositivi formali e informali di controllo del lavoro. Come sappiamo, molte piattaforme di food-delivery utilizzano vecchi sistemi di retribuzione a cottimo per stimolare la produttività dei lavoratori, nuovi sistemi di valutazione per distribuire sui clienti parte del controllo organizzativo, forme contrattuali atipiche per abbattere i costi del lavoro. È in relazione a tali condizioni socio-organizzative che gli algoritmi vengono implementati e incidono concretamente sul modo in cui lavoriamo. Limitarsi a dire che le piattaforme esercitano un controllo algoritmico opaco vuol dire ignorare l’influenza di tali aspetti, riproponendo l’idea che la tecnologia possa avere, in sé, un impatto sul lavoro. Al contrario, pensare alla digitalizzazione da un punto di vista organizzativo vuol dire prendere sul serio l’idea che non siano gli algoritmi a produrre effetti sul lavoro, ma è il modo in cui entrano in relazione con particolari condizioni di lavoro e strutture di potere a trasformare il nostro modo di lavorare. Rimanendo sul caso del food-delivery potremmo chiederci, ad esempio: gli algoritmi che organizzano il lavoro di rider non contrattualizzati e pagati a cottimo funzionano analogamente a quelli di una piattaforma che assume i suoi dipendenti regolarmente, offre loro un salario orario e la possibilità di risolvere personalmente eventuali controversie? Porci queste domande può sembrare banale, ma è utile a riarticolare il nostro immaginario tecnologia, a cercare altri capri espiatori e soluzioni più complesse.

Ad esempio, “rompere la black box” degli algoritmi rendendoli trasparenti e accessibili rischia, di per sé, di non produrre grandi vantaggi ai lavoratori e a chi difende i loro interessi, alla luce di quanto è complesso leggere un algoritmo. Inoltre, potrebbe riprodurre quello che alcuni studiosi delle organizzazioni definiscono il “paradosso della trasparenza”, ovvero il rischio che un maggiore impegno nel fornire informazioni su limitati ambiti dell’organizzazione funzioni da moneta simbolica per rassicurare il pubblico e sviare da ciò che invece rimane oscuro e controverso.
“La gig economy è il futuro del lavoro”
Un certo feticismo attorno agli algoritmi dipende anche dall’aver guardato alle piattaforme della gig economy come modello di lavoro del futuro, concentrandoci su pochissimi settori, molti dei quali emergenti. Peraltro, siamo soliti osservare queste piattaforme in un eterno presente, come se fossero organizzazioni emergenti e sempre uguali a loro stesse, ignorando quanto invece cambiano velocemente. Ripetere la stessa ricerca empirica sulle piattaforme di food-delivery o di trasporti, a distanza di un paio d’anni, rischia di produrre risultati molto diversi, perché le piattaforme evolvono in relazione ai sistemi istituzionali in cui operano, e tali cambiamenti riguardano sia aspetti organizzativi sia tecnologici.
Il termine ‘algoritmo’ è precipitato nel linguaggio comune, e viene utilizzato in modo strumentale per rappresentare idee astratte, come ‘neutralità’, ‘efficienza’, ‘sorveglianza’.
Inoltre, gli studi che hanno esaminato le piattaforme in settori diversi dipingono un quadro organizzativo molto più variegato. I risultati del progetto WePlat, che ha studiato le piattaforme che erogano servizi di cura – psicologici, medici, socioassistenziali – evidenzia che la platform economy non è fatta a immagine e somiglianza di Uber e simili. “Piattaformizzare” i servizi di cura è ben più complesso rispetto al processo di consegna di cibo a domicilio, sia per il livello di istituzionalizzazione del settore del welfare che per la specificità dei servizi erogati. In molti casi, la digitalizzazione produce una resistenza simbolica da parte degli operatori, che vedono il loro status professionale minacciato dall’introduzione di meccanismi tipici delle piattaforme di e-commerce, come le recensioni. In altri casi, l’automazione delle decisioni non è ricercata neppure a livello manageriale, poiché comporterebbe un rimaneggiamento delle relazioni fra utenti e operatori tale da ridurre il valore – anche economico – del servizio stesso. Tanto è vero che il successo di alcune piattaforme in questo settore dipende, in buona misura, dall’aver destinato un’importante quantità di lavoro umano alla gestione delle relazioni con gli utenti.

Oltre la platform economy
Nonostante questo, diverse piattaforme dichiarano di affidarsi ad algoritmi per l’automazione di diverse funzioni organizzative, come il matching fra domanda e offerta, molto più di quanto facciano in realtà. Si tratta solitamente di sistemi algoritmici molto semplici, che operano all’interno di una cornice di automazione mista. Il fatto che le stesse piattaforme nominino esplicitamente gli algoritmi per comunicare con clienti ed investitori ci fa capire come questo termine sia precipitato nel linguaggio comune, e venga utilizzato in modo strumentale per rappresentare idee astratte, come “neutralità”, “efficienza”, “sorveglianza”, a seconda del contesto e del destinatario della comunicazione.
La varietà dei modelli di automazione produttiva, infine, diventa ancora più articolata se estendiamo il nostro sguardo oltre la platform economy ed esaminiamo organizzazioni che non sono digital-native, come le amministrazioni pubbliche, dove spesso i processi di digitalizzazione falliscono proprio perché non contemperano la necessità di organizzare tutto il lavoro invisibile che vi è dietro.

Riarticolare in questo modo le nostre rappresentazioni di algoritmi e tecnologie ci consente di problematizzare maggiormente la riflessione sugli effetti dell’automazione sull’organizzazione del lavoro.
Le tecnologie hanno delle proprietà che abilitano nuovi processi e sono sempre più parte attiva della divisione del lavoro, ma non operano all’interno di uno spazio vuoto.
Il loro concreto funzionamento e il potere che esercitano dipendono, come abbiamo cercato di spiegare, da fattori interni ed esterni alle organizzazioni che non possiamo dare per scontati. Per studiare i risultati dell’automazione e le trasformazioni che, come molti sostengono, i sistemi algoritmici introdurranno in settori tradizionali, abbiamo bisogno di domande nuove.
Ad esempio, dovremmo chiederci come si differenziano i processi di automazione in diversi settori economici, perché assumono una certa forma e come contribuiscono ad alterare le strutture di potere interne. Qual è il ruolo di attori finanziari e istituzionali nel dar forma ai processi di innovazione tecnologica dentro e fuori le organizzazioni. Infine, come i processi di automazione contribuiscono a riconfigurare la divisione del lavoro, ridefinendo i ruoli professionali, le necessità di coordinamento e le dinamiche di conflitto. Intendere la digitalizzazione come un processo organizzativo ci consente di porci tali domande e di ripensare il nostro immaginario algoritmico.