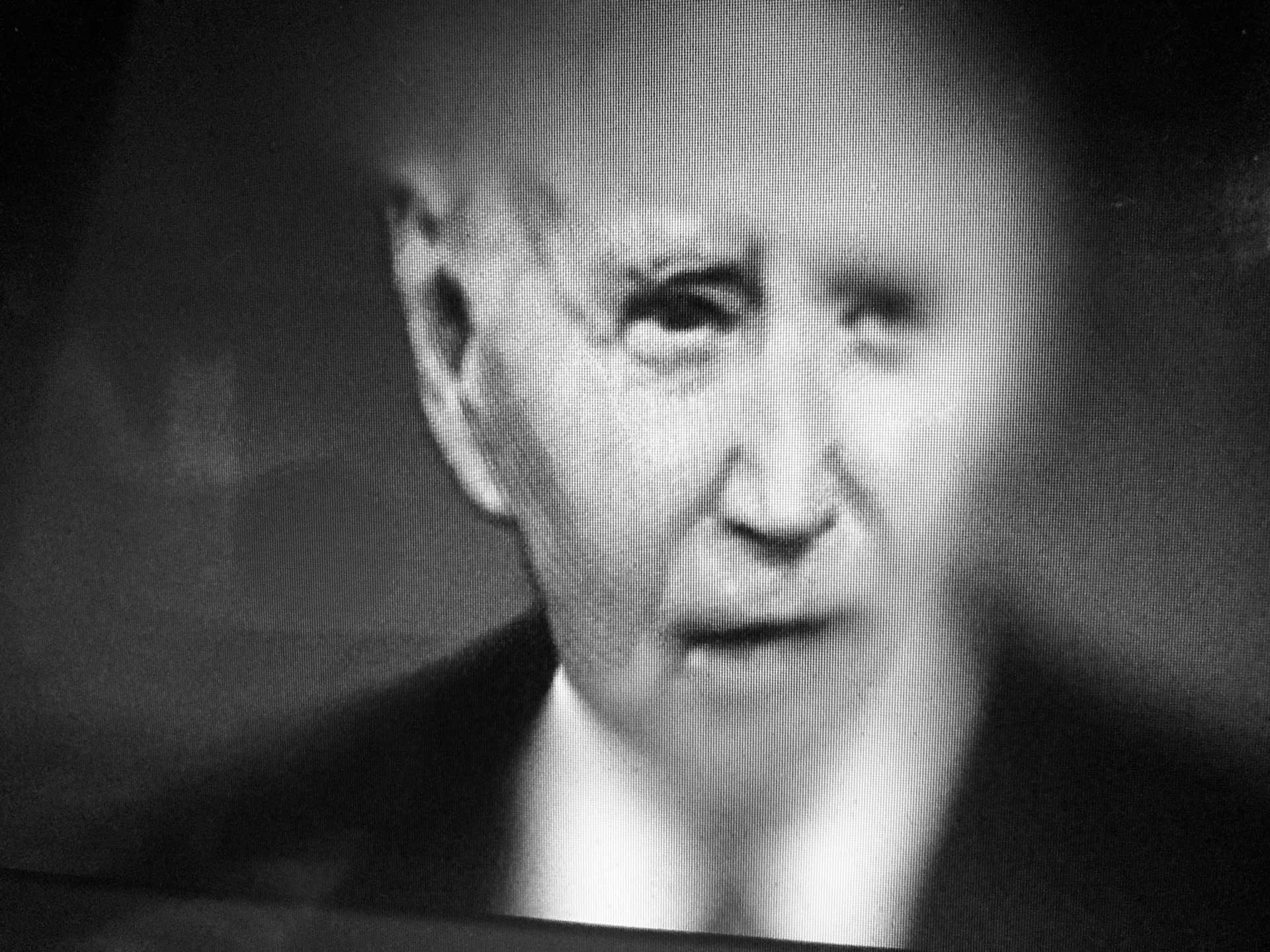Chi non muore si rivede
Pochi lo avrebbero previsto o anche solo immaginato tre anni fa. Dopo l’assalto al Congresso, la tentata eversione successiva alla sua sconfitta elettorale nel novembre 2020, le critiche all’interno dello stesso partito repubblicano, dove anche molti membri del suo ultimo gabinetto – a partire dal Ministro della Giustizia, William Barr – prendevano finalmente le distanze, diventando suoi feroci critici. E invece tutto sembra indicare che Donald Trump sarà nuovamente il candidato repubblicano. Non solo, con un avversario impopolare e patentemente affaticato, ha possibilità concrete di tornare alla Casa Bianca. Sulle ragioni del ritorno di Trump ci s’interroga e si riflette. Così come sull’impatto che esso potrebbe avere sulla politica estera degli Stati Uniti e, di riflesso, sull’ordine internazionale.
Le quattro incognite
Previsioni è ovviamente impossibile farne. A maggior ragione per una figura incostante e volubile come Trump, che durante il suo primo mandato alternò gesti e dichiarazioni incendiari. Come l’ostentato rifiuto di stringere la mano ad Angela Merkel, gli attacchi alla NATO e all’articolo 5 sulla difesa collettiva, le minacce alla Cina e alla Corea del Nord. E d’altra parte, politiche più convenzionali (sempre rispetto alla NATO), talora inefficaci (le guerre commerciali con la Cina) o contraddittoriamente distensive (rispetto alla stessa Corea del Nord ad esempio). Un’altalena acuita anche dal caos e dalla disfunzionalità di un’amministrazione che in pochi anni cambiava quattro Capi di Gabinetto, quattro Consiglieri per la Sicurezza Nazionale, tre Segretari della Difesa, due Segretari di Stato. Un turnover, questo, che si estendeva a tante cariche minori e a cui si aggiungeva la lentezza nelle nomine d’importanti cariche diplomatiche e la preferenza di criteri politici nelle scelte (con Trump, quasi la metà di queste nomine furono “politiche” contro una media storica del 30%).

Ciò premesso, sono quattro in grande sintesi le incognite (e i dossier) principali sulle quali si misurerà la discontinuità di un’eventuale amministrazione Trump ovvero la sua capacità di mettere in asse la retorica (sempre più) radicale e l’azione politica.
A braccetto con Putin
Il primo è rappresentato ovviamente dai rapporti con gli alleati europei e l’impatto sul più importante fronte atlantico oggi: la guerra in Ucraina. Trump minaccia i partner NATO e blandisce Putin come (se non più) di quando era Presidente.
Per inclinazione e incultura istituzionale, usa toni se possibile ancora più estremi, minacciando di lasciare mano libera a Mosca con quei paesi che non contribuiscono a sufficienza alla difesa comune o addirittura di far uscire gli Usa dall’Alleanza.
Prospettiva, quest’ultima, resa in realtà ancor meno praticabile dalla recente decisione del Congresso di approvare una norma che impedisce iniziative unilaterali al riguardo, imponendo la ratifica di una uscita dalla Nato da parte di una maggioranza qualificata dei 2/3 dei senatori, come nel caso dei trattati. È però ipotizzabile che con Trump l’Alleanza Atlantica possa essere svuotata di senso e di contenuto non attraverso un’impossibile defezione statunitense, ma riducendo o azzerando l’impegno diretto di Washington. La NATO – a volte lo dimentichiamo – rimane un’organizzazione federata dalla leadership statunitense. Difficile immaginare una sua sopravvivenza sostanziale in assenza d’essa. È difficile immaginare che un’accelerazione verso un’autonomia strategica europea, finora sempre molto elusiva, possa in breve tempo surrogare la struttura securitaria atlantica. L’impatto principale sarebbe quasi certamente su un fronte ucraino già colpito da questo ciclo elettorale statunitense, con la maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti prona alle pressioni di Trump e indisponibile ad approvare nuovi aiuti militari a Kiev.
Le tensioni con Netanyahu
Il secondo teatro è l’altro fronte di guerra: quello mediorientale. Qui l’imprevedibilità di Trump è se, possibile, ancora maggiore. È vero che fu sotto la sua amministrazione che l’ambasciata statunitense venne trasferita a Gerusalemme e le azioni dei coloni in Cisgiordania si fecero ancora più numerose e violente.
Ma è altresì vero che non sono mancate in tempi recenti le tensioni con Netanyahu e che Trump e famiglia hanno rapporti assai stretti con l’Arabia Saudita, il cui fondo sovrano ha quasi interamente fornito il capitale di 2 miliardi di dollari della società d’investimenti del genero di Trump, quel Jared Kushner che gestì il dossier mediorientale tra il 2017 e il 2021, ottenendo con i cosiddetti “Accordi di Abramo” uno dei più importanti successi diplomatici dell’amministrazione repubblicana.
Al di là di un conflitto d’interessi che lascia davvero senza fiato, andrà compreso come questo legame inciderà sulla politica regionale degli Stati Uniti e sulla posizione che essi assumeranno anche rispetto all’Iran.
I rapporti con la Cina
Terzo: le politiche commerciali e i rapporti con la Cina. Su questo tutta lascia presagire l’adozione di ulteriori misure protezionistiche, da dispiegarsi con poca o nulla selettività, senza discriminare tra alleati e nemici. Andrà capito se si tratta di iniziative in cui l’aspetto simbolico talora prevale sul contenuto, come fu per molti aspetti durante la prima amministrazione Trump, quando a dispetto di dazi, tariffe e guerre commerciali, i deficit esteri (con la stessa Cina) non scesero. Di azioni cioè destinate primariamente all’opinione pubblica interna e all’elettorato conservatore.
Difficile immaginare però che questo non costituirà uno degli ambiti privilegiati d’azione di un’eventuale seconda amministrazione Trump. Da un lato questi provvedimenti sono relativamente facili da adottare. Dall’altro vi è un sostegno ampio e finanche trasversale, a destra come a sinistra, a iniziative di difesa dell’economia nazionale e di “re-industrializzazione”, come peraltro si è visto anche con Biden.
Campi di detenzione per immigrati
Il quarto e ultimo dossier riguarda invece l’immigrazione, il confine meridionale e i rapporti con il Messico.
Qui è quasi scontata una virata verso politiche draconiane, come lasciano presagire anche le proposte che stanno circolando e la stessa iniziale esperienza della prima Presidenza Trump, con l’adozione del famoso “muslim ban”, l’ordine esecutivo con cui si bloccava l’ingresso negli Usa da una serie di paesi a maggioranza mussulmana, poi bloccato dalle Corti.
Nella campagna elettorale in corso, Trump ha usato parole e toni se possibili ancor più ruvidi ed estremi di quanto non aveva fatto otto anni fa. Ha accusato l’amministrazione Biden di facilitare dolosamente l’ingresso negli Usa di migliaia d’immigrati provenienti “da prigioni e ospedali psichiatrici”, che “portano malattie” e “avvelenano il sangue dell’America”. I suoi consiglieri propongono di procedere alla militarizzazione delle politiche sull’immigrazione, usando strutture dell’esercito per creare campi di detenzione dove raccogliere gli immigrati illegali e procedere a una loro rapida espulsione del paese. Al di là dei dubbi sulla praticabilità di queste politiche, è chiaro che si tratta di un ambito dove l’amministrazione avrà, almeno in prima battuta, una autonomia e una libertà d’azione facilmente sfruttabili, anche per il ritorno politico che esse sembrano garantire.
Tutto ciò sarà inevitabilmente accompagnato dall’utilizzo di una retorica aspra e iper-nazionalista: un discorso in cui echeggiano toni grossolanamente eurofobici e spesso scopertamente razzisti, e che già stanno definendo la campagna per le presidenziali di Donald Trump.