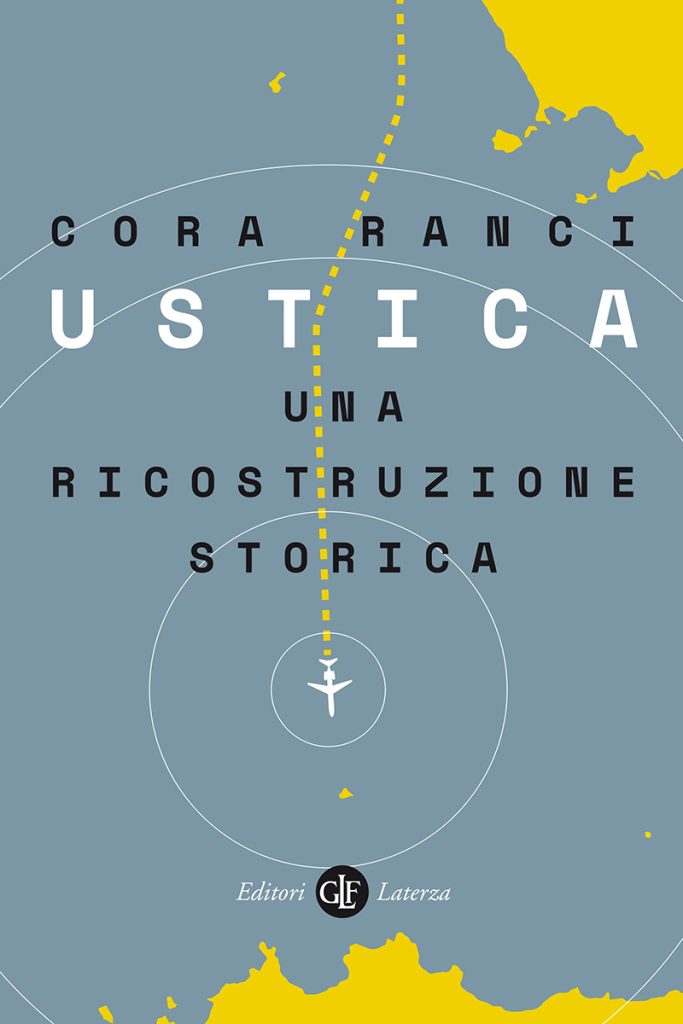Consigli di lettura
Quarant’anni fa, il 27 giugno del 1980, un aereo di linea in volo da Bologna a Palermo si inabissava misteriosamente al largo dell’isola di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita in una strage i cui autori, nonostante innumerevoli indagini e processi, restano ancora ‘ignoti’. Una ricostruzione storica per andare oltre le verità giudiziarie.
Le uniche certezze di quella sera…
Della strage di Ustica sappiamo molto, anche se non tutto. Sappiamo che un aereo civile italiano, un DC-9 Itavia, con a bordo 81 persone – 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio – è decollato da Bologna la sera del 27 giugno del 1980 e non è mai giunto a destinazione. Il pilota Domenico Gatti aveva appena annunciato l’atterraggio a Punta Raisi, Palermo, quando i controllori di volo hanno perso il segnale dell’aereo. I resti del DC-9 vengono ritrovati dai mezzi di soccorso solo all’alba del giorno dopo, al largo dell’isola di Ustica. I corpi recuperati saranno solo 42.
È ormai confermata in sede giudiziaria la ricostruzione secondo cui il DC-9 è stato coinvolto in un’operazione militare aerea non dichiarata e mai del tutto chiarita. La tesi più accreditata è, come noto, quella del missile: l’aereo civile italiano è stato colpito da un ordigno sganciato da un caccia in manovra d’attacco.
Questa versione dei fatti è stata sostenuta dalla maggior parte delle perizie e accolta come quella più credibile dalle tante sentenze pronunciate in sede civile tra il 2003 e il 2013. Vi è un’altra teoria, sostenuta da una perizia del 1999, secondo cui sarebbe stata una “quasi collisione” con l’aereo aggressore a provocare l’effetto esplosivo che ha ridotto il DC-9 in migliaia di pezzi.
L’aereo fantasma
Ciò che è certo che un aereo militare ha effettuato una manovra di attacco in direzione del DC-9, provocandone l’esplosione. Secondo la ricostruzione del giudice Rosario Priore – che ha condotto le indagini sul caso dal 1990 al 1999 – l’attacco avrebbe dovuto avere come obiettivo un altro aereo militare che stava volando “nella scia” e “sotto la pancia” del ben più grande DC-9, per non essere visto dai radar – anche se la sua presenza anomala ha comunque lasciato delle tracce.
Si è ipotizzato che questo “aereo fantasma” fosse libico: cosa verosimile dal momento che all’epoca della strage non era infrequente che MIG-23 libici (caccia di fabbricazione sovietica) sorvolassero lo spazio aereo italiano senza essere autorizzati. Si recavano in Jugoslavia per addestramenti e riparazioni, in forza di un accordo segreto di cui i nostri servizi militari di intelligence (il Sismi) erano al corrente e che il nostro governo di fatto tollerava – plausibilmente suscitando irritazione nell’alleato americano. È di poche settimane dopo la strage di Ustica il ritrovamento della carcassa di un mig libico sui monti della Sila, in Calabria: altro episodio avvolto nell’opacità, di cui le autorità libiche e italiane hanno sicuramente dato una spiegazione falsa.

Il contesto internazionale
Il contesto era quello della guerra fredda, che proprio nel 1980 era tornata a stringere le sue maglie e a mostrare il suo volto più temibile. Usa e Urss quell’estate erano presenti massicciamente con portaerei proprio nel Mediterraneo, area attraversata da tensioni e instabilità la cui portata era percepita come estremamente pericolosa. I rapporti tra la Libia di Gheddafi, vicina al blocco sovietico, e gli alleati dell’Italia, Usa e Francia, erano particolarmente tesi. Ma l’Italia, membro fondatore della Nato e avamposto militare dell’Alleanza atlantica nel Mediterraneo, non intendeva rinunciare a preservare gli enormi interessi economici che la legavano alla sua ex colonia – e forse anche a un margine di autonomia in un’area che alcuni consideravano di storica proiezione della politica estera italiana.
Come noto, non esistono prove che permettono di individuare i colpevoli per la strage, ma il campo delle ipotesi è ormai ristretto a Usa e Francia. Gli elementi a disposizione sono diversi: dai radar che mostrano la presenza di numerose tracce aeree riferibili a questi paesi, alle intercettazioni telefoniche di quella notte, in cui gli operatori del traffico aereo parlano chiaramente di “caccia americani”. Dal canto loro, gli Usa all’indomani della strage hanno dichiarato che nessun loro mezzo si trovava in volo e che la portaerei Saratoga, nel golfo di Napoli, aveva i radar disattivati.
Nemmeno Parigi ha collaborato, dapprima negando che la base militare còrsa di Solenzara fosse attiva quella sera, per poi ammettere, molti anni più tardi, che effettivamente era invece operativa: ma a quel punto gli ufficiali interrogati non ricordavano più nulla. Né gli Usa né la Francia hanno collaborato in maniera soddisfacente con la nostra giustizia, al punto che il marzo scorso la Procura di Roma ha annunciato l’intenzione di archiviare l’inchiesta, menzionando anche la poca trasparenza nella collaborazione avuta dai due paesi, che hanno trasmesso informazioni incomplete, non riscontrabili e in alcuni casi addirittura fuorvianti.
La colpevolezza della Francia è stata sostenuta anche dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga – che all’epoca della strage era capo del governo – e, più recentemente, da Giuliano Amato, che della vicenda si è occupato negli anni ‘80 da sottosegretario. Esternazioni autorevoli, che non hanno però prodotto reazioni significative a Parigi.

Tra depistaggi e ricerca della verità
Il problema di Ustica, è che mancano le prove per poter mettere davvero un punto a questa vicenda – cosa che lascia aperto un margine di spazio all’interno del quale è ancora in corso un costante tentativo di insinuare il dubbio, di screditare quanto ormai consacrato dalla giurisprudenza, proponendo la fantasiosa tesi della bomba a bordo dell’aereo, che non ha mai trovato riscontri in sede giudiziaria.
Non ci sono prove perché è stata messa in campo una precisa azione di insabbiamento e condizionamento delle indagini che, purtroppo, ha fatto sì che Ustica entrasse a pieno titolo nel novero delle stragi italiane, accomunate dalla pratica del depistaggio. I tracciati radar non consegnati alla magistratura, quelli manomessi e stranamente lacunosi, i registri con le pagine strappate, i tanti “non ricordo”, le morti sospette tra i militari, le veline con cui i servizi militari caldeggiavano la tesi del cedimento strutturale, mettendo alla gogna la compagnia Itavia, oggi risarcita – fuori tempo massimo – proprio per il conclamato depistaggio.
Il silenzio delle istituzioni
Se non fosse stato per la forza di qualcuno che si è messo a bussare alla porta delle istituzioni chiedendo “perché?” – la voce più forte è quella di Daria Bonfietti che dal 1988 presiede l’Associazione parenti vittime, ma non dimentichiamo l’apporto della stampa e del compianto Andrea Purgatori – ad oggi non sapremmo che su Ustica è stata la difesa della ragion di Stato, sull’altare della quale sono state sacrificate non solo 81 vite innocenti, ma anche – ancora una volta – il patto di fiducia tra Stato e cittadini. Anche questa è storia italiana: nel 1980, un aereo civile è stato abbattuto da paesi tuttora alleati del nostro paese, e nessuno ha mai ritenuto di dover dare una spiegazione.