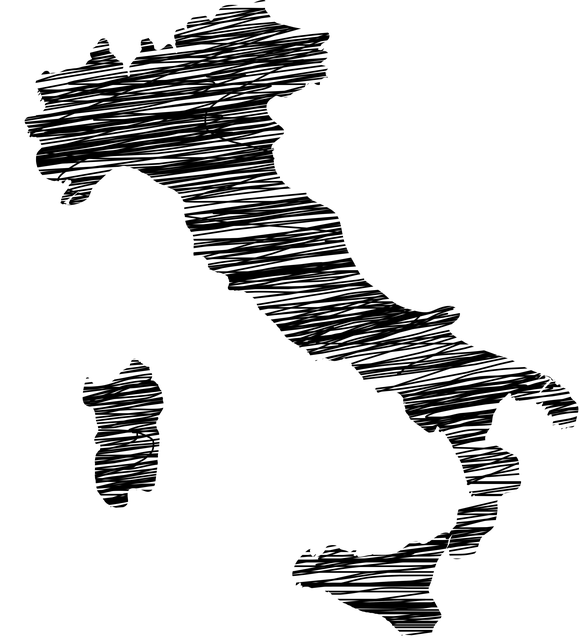Leggi lo speciale editoriale
dedicato al ciclo di Workshop
1989. Sotto le macerie del muro
Testo di Valeria Finocchiaro

Il contesto storico
Il processo delle privatizzazioni in Italia fu un lungo iter legislativo che mosse i suoi primi passi già nel 1991, con un decreto-legge che conteneva “la prima norma generale di privatizzazione”, come ha scritto Sabino Cassese in un articolo del 1996. Inoltre, quello della privatizzazione delle aziende pubbliche fu un processo vissuto – e ricordato – dall’opinione pubblica come un processo opaco e poco chiaro, più che come un cammino graduale che vide il coinvolgimento di quasi tutte le forze governative italiane.
Di quel mutamento epocale furono protagoniste le classi dirigenti e non la società stessa, che ne vide le conseguenze ma non ne comprese forse appieno le ragioni.
Il quarto workshop organizzato da Fondazione Feltrinelli per il ciclo “1989. Sotto le macerie del Muro” si è concentrato proprio sul fenomeno delle privatizzazioni e, con l’aiuto di diversi ospiti, ne ha affrontato la genesi e le conseguenze.
Ha aperto i lavori Marc Lazar, ponendo agli ospiti una serie di domande utili a inquadrare storicamente il fenomeno attraverso una serie di coordinate condivise. I settori industriali interessati dalle privatizzazioni furono: telecomunicazioni, energia, elettricità, gas, trasporti e banche. Per quanto riguarda la cronologia, il primo atto legislativo ufficiale fu il già menzionato decreto-legge del 1991 ad opera del quarto governo Andreotti, anche se, come messo in luce dagli ospiti nel corso del workshop, alcuni eventi significativi precedettero quel decreto, come la cessione di Alfa Romeo a Fiat nel 1986. Nel 1997 venne invece privatizzata Telecom Italia, nel 1998 fu la volta di ENI e nel 1999 quella di ENEL.

Temi e domande
Una volta fissato il contesto storico, alcune domande individuate da Lazar costituiscono il filo conduttore delle riflessioni successive.
Come mai l’idea delle privatizzazioni è arrivata in Italia? Ci fu un’influenza esterna o si trattò di un’idea endogena? Chi furono gli attori e le personalità più in vista responsabili del processo? E quale fu il ruolo di Confindustria? Quali paesi furono considerati dei modelli? Quali furono le motivazioni – politiche o economiche – per mettere in atto quel processo? Vi fu, nelle classi politiche italiane, un sostanziale consenso nei confronti delle privatizzazioni, o è possibile ricostruire un dibattito interno fatto di resistenze e obiezioni più o meno forti? Spostando poi il focus sulle forze di sinistra, quale fu il rapporto tra le privatizzazioni e la sinistra, e come spiegare il fatto che, tutto sommato repentinamente, furono proprio gli ex comunisti che avevano fondato il PDS a convertirsi alle privatizzazioni quasi senza colpo ferire?
E ancora, questa “conversione” avvenne davvero in modo repentino, o fu piuttosto il risultato e il compimento di una fase politica avviata in precedenza? Possiamo ricostruire il dibattito interno ai due principali partiti progressisti dell’epoca, il Partito Socialista e il Partito Comunista? Quale fu la giustificazione teorica che guidò quelle scelte? Fu più l’influenza dei socialisti a pesare, o quella dei democristiani di sinistra guidati da Romano Prodi? E quale fu la reazione dei sindacati, e della CGIL in primo luogo?
È possibile per noi oggi ricostruire uno sforzo pedagogico e chiarificatore da parte dei partiti e dei governi, oppure la politica si preoccupò poco di coinvolgere i cittadini in quelle scelte? E quale fu l’effetto della discesa in campo di Berlusconi nel ‘94?
Parlando poi delle privatizzazioni in generale, si può distinguere fra privatizzazioni di sinistra e privatizzazioni di destra, oppure è più corretto affermare che non ci fu alcuna sostanziale differenza? E qual è oggi il bilancio che fa il Partito Democratico dell’esperienza delle privatizzazioni?

Rispetto all’Unione Europea la sinistra non ha avuto sempre le posizioni che noi oggi vediamo egemoni, né tantomeno esse erano universalmente accettate da tutte le correnti interne.
Lazar ha poi invitato a riflettere sull’eredità delle privatizzazioni nella società italiana. Una vulgata molto diffusa all’epoca in cui vennero fatte sosteneva che esse avrebbero restituito efficienza alle istituzioni pubbliche e che avrebbero rinfocolato la fiducia dei cittadini verso la politica, ormai in piena crisi di rappresentanza.
Fu davvero così? E se invece, ha sostenuto Lazar, accadde piuttosto il contrario, ovvero che le privatizzazioni comportarono un aumento della diffidenza nei confronti dello Stato? La società italiana, d’altronde, fin dalla sua nascita, è sempre stata caratterizzata da una forte diffidenza dei cittadini verso il governo: che effetto ebbero su questo storico sentimento le privatizzazioni? E in riferimento alla sinistra: possiamo dire che le privatizzazioni hanno accelerato quel cambiamento antropologico e culturale verificatosi in tutta Europa in seguito al crollo del Muro e delle ideologie, che penalizza (soprattutto elettoralmente) la sinistra, mentre proprio la sinistra ne fu l’attore principale, per effetto di un meccanismo paradossale e imprevisto?

Il contesto internazionale:
sguardi a confronto
A colloquio con Giandomenico Piluso, Università degli Studi di Torino
Gli ospiti hanno cominciato a inquadrare in primo luogo il contesto internazionale, in modo da comprendere gli eventi italiani alla luce delle sue influenze esterne. Come fa notare Giandomenico Piluso, le privatizzazioni non furono un fenomeno solamente italiano, poiché esse si inseriscono in una fase di profonda ristrutturazione delle istituzioni economiche che riguardò tutto il mondo occidentale: intorno agli anni ‘ 70, avvenne un cambio di paradigma teorico nelle discipline economiche che ebbe dei riflessi anche nelle politiche economiche, investendo i mercati, la finanza, le imprese. Si trattò di una vera e propria battaglia delle idee, in cui a vincere fu il principio secondo cui ‘il mercato avrebbe dovuto sostituire la società. Avvenne in sostanza uno switch teorico importante nelle discipline economiche, che da quel momento furono ampiamente influenzate dalla procedura di interpretare i ‘dati’ alla luce di teorie economiche preconcette, spacciando questa interpretazione soggettiva per una ‘descrizione oggettiva’.

A colloquio con Susanna Maria Cafaro, Università del Salento
Anche Susanna Maria Cafaro mette in luce le dinamiche globali in cui le privatizzazioni italiane mossero i loro primi passi. Negli anni ‘90 i trattati europei ratificano dei processi che sanciscono il limitato spazio di manovra politico degli stati membri. Interessante notare, a questo proposito, che a capo della commissione europea c’è il socialista francese Jaques Delors (dal 1985 al 1995), il quale imprime alla sua presidenza l’influenza dell’ordoliberismo tedesco (il quale prevede, accanto al libero mercato, anche tutta una serie di “correttivi”, come ad esempio il divieto di trust) e che porta a compimento il consolidamento del mercato comune con il Trattato di Maastricht. Se da un lato, continua Cafaro, è vero che l’Italia dovette adattarsi a queste grandi tendenze storiche, è senz’altro importante sottolineare – a dispetto della vulgata deresponsabilizzante oggi in voga, che sostiene che tali processi furono del tutto imposti dall’esterno – il ruolo attivo della classe dirigente italiana.

A colloquio con Andrea Fumagalli, Università degli Studi di Pavia
Andrea Fumagalli ha aggiunto un altro tassello per completare il quadro europeo: nel 1998 il Trattato siglato dal Consiglio europeo a Cardiff, insistendo sulla necessità, per i vari paesi membri, di promuovere “riforme strutturali” per migliorare l’integrazione economica, sancì di fatto la liberalizzazione delle public utilities, ovvero la trasformazione in società per azioni delle aziende che erogavano servizi pubblici (come trasporti ed energia). In questo passaggio, naturalmente, lo Stato avrebbe potuto mantenere un controllo, ad esempio utilizzando la Golden Share (cosa che perlopiù non avvenne); si trattò di un passaggio di paradigma epocale: si passò cioè dall’impresa stakeholder all’impresa shareholders, cioè da un modello di impresa in cui gli interessi delle parti interessate, come dipendenti, comunità e governo, erano prioritari, a un modello d’impresa orientato agli azionisti (shareholders), dove l’obiettivo principale era di massimizzare il valore per questi ultimi.
La finalità dell’erogazione di servizi, dunque, non fu più quello della pubblica utilità, bensì quello dell’ottenimento di dividendi e della massimizzazione dei profitti. Fu questo in effetti il modello che si impose nel processo di privatizzazione e che ha caratterizzato il modo di gestire la cosa pubblica negli ultimi trent’anni: il new public management, basandosi su principi e pratiche di gestione tipiche del settore privato, non fece altro che accentrare la gestione finanziaria a scapito delle esigenze sociali.
Eppure, l’Italia, a parere di Fumagalli, non ha mai conosciuto una rivoluzione manageriale come gli Usa o il Regno Unito. In Italia tutt’oggi anche le imprese più grandi, anche le imprese quotate in borsa, hanno di solito una gestione familiare (si pensi al colosso Ferrero), il che dimostra l’inesistenza di una scuola manageriale italiana. Gli esempi di buone pratiche di management nel nostro paese sono invece riconducibili soprattutto al campo statale: negli anni ‘70, ad esempio, la classe manageriale dell’ENI faceva scuola in tutta Europa.
E, mentre si diffondeva nel paese la retorica dell’efficienza privata, in realtà le imprese private italiane non furono mai al livello delle grandi imprese inglesi e americane; in luogo della celebratissima efficienza, in Italia si ebbero piuttosto monopoli e rendite di posizione. Fu proprio questo, ha concluso Fumagalli, il grande tallone d’Achille italiano: la carenza di cultura manageriale, cosa che si tradusse anche in carenza di cultura dell’innovazione e del rischio. L’unico effetto delle privatizzazioni fu in sostanza quello di rimpinguare le finanze pubbliche a beneficio soprattutto dei governi che erano in carica: non a caso il governo Prodi, che è quello che più di tutti ha privatizzato grosse fette di aziende pubbliche, può vantare di essere stato il governo più efficiente nel ridurre il rapporto fra debito e Pil. Quale che fu il costo sociale di questa operazione è ancora materia di dibattito.
In sintesi: allo stato attuale sembra difficile definire un minimo comune denominatore fra i vari partiti di sinistra quando ci si addentra nel delicatissimo campo delle relazioni internazionali, oltre che in quello economico.

A colloquio con Luca Mocarelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Quando si parla di privatizzazioni in Italia è necessario fare un passo indietro: come ha fatto notare Luca Mocarelli, la stagione dell’industria di Stato – con la sua imponente e ingombrante retorica – fu inaugurata dal fascismo, che creò l’IRI, e questa fu l’unica eredità del regime che nessuno, almeno fino a un certo punto, si sognava di mettere in discussione: l’idea dello Stato-imprenditore, infatti, era sentita come decisiva e vitale da tutto lo schieramento politico poiché rispondeva – e sembrava risolvere – alcune fragilità strutturali dell’economia italiana, che lo Stato si portava dietro dai tempi dell’unificazione.
L’Italia fu, per gran parte della sua storia iniziale, un paese prevalentemente agricolo, e il sorpasso dei lavoratori impiegati nell’industria su quelli impiegati nell’agricoltura avvenne solo nel 1958, in pieno miracolo economico: l’industria di Stato aveva dunque il compito di accelerare quel processo di modernizzazione rispetto al quale l’Italia sembrava essere rimasta indietro.
Fino agli anni ‘50, ha continuato Mocarelli, gli ingranaggi di questo Stato-imprenditore erano ben oliati grazie al lavoro di una generazione di ottimi manager, come Enrico Mattei; le cose cominciarono tuttavia a cambiare negli anni’60, per poi peggiorare drasticamente nel ventennio ‘70 e ‘80: è qui che comincia a diffondersi quel sentimento popolare diffuso contro l’inefficienza pubblica, contro i “carrozzoni”, come venivano spregiativamente chiamate le industrie di Stato, e che accompagnò il destino di queste ultime fino all’epilogo della stagione di partecipazione statale, nel 1992.

Unione europea:
Dall’Inghilterra della Thatcher
alla Francia di Chirac
 È bene sottolineare che l’Italia non fu il primo paese europeo a dismettere le proprie industrie pubbliche: in Inghilterra negli anni ‘80 c’erano già state le grandi privatizzazioni del governo Thatcher, che aveva venduto diverse società statali, tra cui British Telecom, British Gas e British Airways. Anche la Francia fra gli anni ‘80 e ‘90 aveva avviato un programma di privatizzazioni sotto il governo di Francois Mitterrand e poi di Jaques Chirac, in cui furono vendute la Compagnie Générale d’Electricité (CGE) che diventa Vivendi, e France Télécom (oggi Orange).
È bene sottolineare che l’Italia non fu il primo paese europeo a dismettere le proprie industrie pubbliche: in Inghilterra negli anni ‘80 c’erano già state le grandi privatizzazioni del governo Thatcher, che aveva venduto diverse società statali, tra cui British Telecom, British Gas e British Airways. Anche la Francia fra gli anni ‘80 e ‘90 aveva avviato un programma di privatizzazioni sotto il governo di Francois Mitterrand e poi di Jaques Chirac, in cui furono vendute la Compagnie Générale d’Electricité (CGE) che diventa Vivendi, e France Télécom (oggi Orange).
Ma, in Francia, è anche e soprattutto un governo di sinistra, guidato dal socialista Lionel Jospin, che tra il 1997 e 2002 privatizza ancora di più. In Italia però il ruolo dello Stato nell’impresa era particolarmente significativo, tanto è vero che nel momento in cui questo processo inizia vengono registrate entrate significative nelle casse dello Stato; detto in altri termini, il fatto che le privatizzazioni abbiano comportato un grosso aumento delle finanze pubbliche dà la misura di quanto lo Stato possedesse, in termini di aziende e imprese.
In ogni caso, per le varie privatizzazioni e in particolare quella del settore telefonico, è importante notare che si scontrarono quasi sempre due orientamenti, quello che credeva preferibile la presenza di un nucleo duro di azionisti, e quello che riteneva preferibile un azionariato diffuso e popolare. Prevalse il primo, come dimostra il caso di quella che venne definita ‘la madre di tutte le scalate finanziarie’, quella di Olivetti ai vertici di Telecom (1998). Il primo governo Prodi, allora in carica, avrebbe potuto bloccare quella scalata di potere tramite la Golden Share (provvedimento che impone una percentuale massima di azioni che può passare sotto il controllo privato) ma scelse di non opporsi, e alla fine di quella memorabile impresa finanziaria la maggior parte delle azioni era posseduta da capitale straniero.
 Erano gli anni in cui si diffuse – piuttosto velocemente e senza la verifica dei fatti – l’idea che la gestione privata fosse migliore e più efficiente di quella pubblica. Eppure, come dimostra un report pubblicato dalla Corte dei conti nel 2010, una volta in mano ai privati quelle aziende non furono affatto più efficienti: al contrario, l’aumento di profitto che si registrò fu dovuto al fatto che esse aumentarono le tariffe, senza tuttavia che a questo aumento corrispondessero investimenti per migliorare i servizi.
Erano gli anni in cui si diffuse – piuttosto velocemente e senza la verifica dei fatti – l’idea che la gestione privata fosse migliore e più efficiente di quella pubblica. Eppure, come dimostra un report pubblicato dalla Corte dei conti nel 2010, una volta in mano ai privati quelle aziende non furono affatto più efficienti: al contrario, l’aumento di profitto che si registrò fu dovuto al fatto che esse aumentarono le tariffe, senza tuttavia che a questo aumento corrispondessero investimenti per migliorare i servizi.
I grandi stravolgimenti politici, economici e geopolitici ebbero naturalmente anche dei corrispettivi nel costume della società: come fa notare Lorenzo De Sio, la nascita, la diffusione e il successo della televisione negli anni ‘80 mostrò agli italiani, convincendoli nel profondo, che un’Italia privata non solo poteva esistere, ma era proprio ciò che essi volevano, poiché sembrava rispondere a una serie di bisogni e desideri che cominciavano a farsi strada fra la popolazione: tra gli altri, l’utopia berlusconiana del self made man.
E fu proprio nel momento della celebre discesa in campo di Silvio Berlusconi, nel 1994, che l’Italia visse un collasso paragonabile a quello dell’Unione Sovietica nel 1989, sostiene Goffredo Adinolfi. In questo quadro, almeno nell’elettorato progressista, la questione morale di Berlinguer contribuisce, a modo suo, a diffondere quel senso di diffidenza verso la partecipazione dei partiti al mondo imprenditoriale, vista come un fattore di inevitabile corruzione.
La Corte costituzionale
Massimiliano Boni ha analizzato infine il fenomeno delle privatizzazioni focalizzandosi sull’atteggiamento della Corte costituzionale riguardo alle riforme del periodo. Durante questo arco temporale tre ministeri furono aboliti, tra cui il Ministero delle partecipazioni statali, che aveva creato l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale).
Questo cambiamento rappresentò un significativo spostamento verso una maggiore liberalizzazione economica e un ruolo più limitato dello Stato nell’economia. Inoltre, la Corte costituzionale accettò alcuni quesiti referendari come quello sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Tali referendum riflettevano un desiderio di cambiamento e di maggiore responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. In generale, a parere di Boni, il periodo delle privatizzazioni fu caratterizzato da un “forte vento di semplificazione”, cioè da un impegno per ridurre l’intervento dello Stato nell’economia e semplificare le strutture burocratiche, spingendo verso un maggior coinvolgimento del settore privato nell’erogazione di servizi pubblici e nella gestione delle imprese.
Avviandosi verso la conclusione del workshop, è emerso un quadro complesso, del quale gli ospiti hanno tracciato un bilancio piuttosto negativo. Da un lato, come si è visto, vi furono dei processi storici internazionali in atto che coinvolsero tutti i paesi europei; dall’altro, la classe dirigente italiana, in particolare le forze di governo, non si opposero mai a quel “vento di semplificazione”, ritenendo che fosse più impellente migliorare i bilanci piuttosto che puntare sulle compagnie statali. Tuttavia, come ha affermato Luca Mocarelli sintetizzando una sensibilità condivisa dagli ospiti, le privatizzazioni, unite alla strutturale mancanza di cultura manageriale, hanno reso l’Italia
“un paese che è diventato ricco senza mai riuscire a modernizzarsi davvero”. E, poiché esse si risolsero in gigantesche scalate di potere e monopoli, si può dire che “le privatizzazioni tradiscono l’obiettivo per cui erano nate, ovvero la partecipazione equa al mercato” (Cafaro).
In conclusione, il workshop ha contribuito a gettare luce su alcuni aspetti delle privatizzazioni, processo che più di ogni altro, nella nostra storia recente, ha segnato un’importante trasformazione economica e politica del paese, con effetti che sono ancora oggetto di riflessione e analisi nella memoria storica collettiva. Ciò che è emerso non è solo il tema del ruolo dello Stato nell’economia, bensì anche quale sia stato (e debba essere) il coinvolgimento democratico dei cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro del paese.