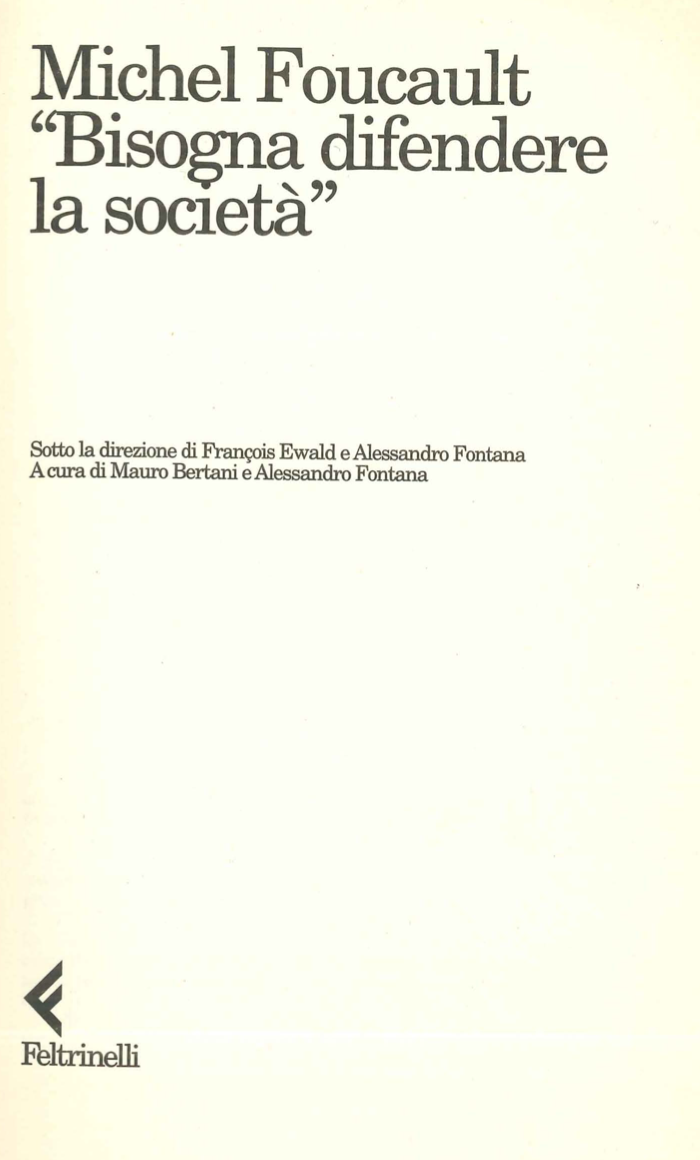Come si racconta la guerra?
Maria Grazia Cutuli parte per l’Afghanistan all’indomani dell’attacco alle Twin Towers (11 settembre 2001) e alla vigilia dell’avvio di Enduring Freedom, che ufficialmente inizia il 7 ottobre 2001. È il nome in codice ufficialmente utilizzato dal governo degli Stati Uniti d’America per designare alcune operazioni militari avviate dopo gli attentati dell’11 settembre.
Cutuli è consapevole che lo scenario che andrà a incontrare – e che cercherà di raccontare al lettore italiano – non è solo il fronte di una guerra. È una società che attraversa da venti anni una guerra e che ha compiuto un processo per molti aspetti irreversibile.
La guerra è un elemento della sua quotidianità in cui si definiscono fortune e sfortune economiche, in cui si costruiscono gruppi di interesse locale e sistemi di relazioni internazionali; dove conta moltissimo il traffico sporco dell’oppio e chi lo gestisce; dove sono essenziali le retoriche dell’identità culturale e l’uso politico della storia. Dove, tra l’altro, conta tantissimo la fedeltà al proprio gruppo di appartenenza.
Uno scenario dove molti dichiarano la sacralità della vita, ma la vita degli altri non conta.
Da tempo andare a fare il cronista di guerra non ha più il senso del racconto appassionato cui si è costruita al cinema la figura del giornalista al fronte. In comune c’è la possibilità di morire o perché si va troppo sotto il fuoco incrociato, o con la disavventura di mettere un piede su una mina come capita a Robert Capa (1913-1954). Oppure non è il tempo dell’osservazione di maniera sugli usi e costumi degli abitanti del luogo – a cui ci ha abituato Ernest Heminguay (1899-1961).
L’inviato di guerra
L’inviato di guerra a partire dagli anni ’60 – da Oriana Fallaci (1929-2006), in Vietnam e poi in Messico; a Tiziano Terzani (1938-2004) nella Cambogia sconvolta dai cadaveri che popolano le molte strade del paese dopo la vittoria degli Khmer rossi (1977) alle inchieste sul traffico sporco che gira intorno alla guerra e che propone Ilaria Alpi (1961-1994) nella Somalia – non ha né la vita facile, né la vita felice. La sua è una condizione a rischio perché ogni volta che descrive la guerra scava nel non detto della guerra in corso.
L’effetto è che nessuno esce da quella descrizione con le “mani pulite” e, per quanto possa dichiarare la sacralità della propria causa, il punto è proprio la non coincidenza tra la sacralità della causa, la missione e i gesti che compie. Ma anche l’aspetto criminale del proprio modo di rapportarsi al prossimo (sia questo: donne; bambini; anziani; stranieri; cittadini del proprio paese ma di differente fede politica o religiosa;…) o di anteporre i propri interessi economici (spesso inconfessabili) alla causa che intende difendere o di cui si dichiara paladino.
L’inviato di guerra ora non è più solo, e nemmeno principalmente, un professionista della penna che dalla scena che ha sotto gli occhi racconta a chi sta lontano cosa per davvero stia succedendo sul campo di battaglia.
È, invece, una voce che fuori dal coro, racconta fatti, porta al tavolo delle cose da sapere quei meccanismi e atti che ridefiniscono il volto dei diversi protagonisti.
L’eclissi della “missione di guerra”
L’effetto è l’eclissi della “missione di guerra” come atto di generosità e l’emergere della scelta dell’atto di guerra e della cultura della guerra come macchina che dà forma e volto alla politica.
Per cui superare o rimuovere la guerra non è più solo possibile facendo tacere le armi o facendo crescere la consapevolezza di una fine del conflitto armato, ma mettere a nudo i sistemi politici, le strutture economiche, le credenze culturali che intorno alla guerra si muovono e che definiscono il senso della politica.
Ora l’inviato di guerra, quando racconta la guerra per davvero e non si limita a descrivere la “guerra-battaglia”, descrive la “guerra-sistema” e associa al proprio mestiere di “descrivere i fatti” una diversa funzione del suo mestiere.
Essenzialmente si pone tre domande:
- La prima: che cosa si va a cercare dentro a uno “scenario di guerra”? Il tema di genere, uomini e donne? Le economie di guerra? Le mentalità e le culture di guerra?
- La seconda: davvero la guerra è, come recita un detto comune, la continuazione della politica con altri mezzi o invece non è più rispondente al vero che la politica sia la continuazione della guerra con altri linguaggi?
- La terza: come si traduce “Guerra” a un pubblico che la guerra non la vive in diretta, sulla propria pelle, bensì non la vede da 45 anni? Che cosa si racconta? Come si fa a tenere viva l’attenzione? Perché non è sufficiente raccontare i drammi, poi bisogna fare in modo che quelle storie siano uno stimolo a riflettere sulla sua realtà per il lettore che sta lontano.
Michel Foucault
La piattaforma mentale che sottostà a queste tre domande discende da un percorso culturale e da un apprendistato intellettuale che hanno echi profondi con il laboratorio che Michel Foucault (autore che è tra le letture di formazione di Maria Grazia Cutuli) apre a metà anni ’70 nel momento in cui sta chiudendo Sorvegliare e punire, dove il tema del carcere non è concentrato sulla pena, ma sul sistema, ovvero l’insieme delle procedure volte a incasellare, controllare, misurare, addestrare gli individui, al fine di renderli docili e utili nello stesso tempo.
La lezione d apertura al corso che Michel Foucault tiene al Collège de France nell’inverno 1976, è centrata su questo assunto che poi Foucault sviluppa e amplia e intorno alle sue indagini su quello che denomina «governo della vita» che si sostiene intorno al tema della «sicurezza». Più direttamente: descrivere la guerra non è più raccontare l’eccezione rispetto a una norma, confrontare la nuda vita, priva di garanzie e diritti che riguarda chi vive laddove la guerra si consuma, descrivendola a chi «lontano», a casa propria, vive in tranquillità.
Descrivere la guerra significa scavare nella quotidianità della violenza che la condizione di guerra rende scoperta anche laddove la guerra non c’è.
In una situazione di guerra i codici e le pratiche di violenza diventano solo ampiamente più diffuse, ma non cambiano nella sostanza: lo stupro diventa di massa, ma lo stupro appartiene già alla nostra società; la sopraffazione violenta diventa manifesta, ma il classismo, il razzismo, lo sfruttamento del più debole è già qui da noi un codice di violenza; la polarizzazione fra ricchi e poveri diventa nella guerra manifesta, con il mercato nero, l’accaparramento delle risorse, le speculazioni, ma la polarizzazione fra chi ha e chi non ha è già violenta qui da noi.
Maria Grazia Cutuli e i molti altri giornalisti che hanno sperimentato in questo ultimo mezzo secolo che cosa voglia dire descrivere la guerra questo hanno sperimentato, purtroppo spesso in maniera irreversibile sul proprio corpo: che la guerra non è un affare di onore da dimostrare, ma è interessi, violenza – spesso gratuita –, affari, mercato nero.
E che raccontarla significa scrivere non un’inchiesta, ma costruire una controinchiesta e chiedere che i responsabili rispondano, non a loro, ma a un’opinione pubblica ora, informata.
Clicca qui per leggere un estratto da Gino Strada, Buskashì. Viaggio dentro la guerra, Feltrinelli, Milano 2002.

Clicca qui per leggere un estratto da Michel Foucault, Bisogna difendere la società, Feltrinelli, Milano 1976.