Noi vorremmo non perdere Tomás Maldonado.

Per raggiungere questo obiettivo serve coltivare le sue competenze e proporre di scavare intorno ai suoi percorsi e le sue inquietudini. Ma soprattutto non vorremmo che si disperdesse una funzione.
Per lungo tempo “intellettuale” nell’ultimo secolo e mezzo si associava a una parola: guastafeste, un’intelligenza critica che affermava la verità contro il potere. Zola, Orwell, Arendt, Sartre e Pasolini, per indicarne solo alcuni, hanno incarnato questa funzione in momenti diversi. Oggi questa parola ha perduto il suo fascino o forse ancora meglio: ha trasferito il suo fascino nei personaggi che invadono i nostri schermi televisivi e alternativamente o stanno lì in studio atteggiandosi a «brutti ceffi» o parlano per tranquillizzarci.
Se c’è una crisi dell’intellettuale è proprio qui.
L’inquietudine
L’inquietudine che ci proponiamo di conservare, di tutelare e di mantenere è quella che nasce dalla diffidenza contro il «sapere facile». Vecchia lezione di Gramsci, quella che Maldonado propone. Il lavoro intellettuale non è estetica del pensiero, ma è fatica di pensare. Un «corpo a corpo» con le cose che si tenta di stringere, che ci si sforza di mettere a giorno, e di proporre alla pubblica discussione.
L’impegno non è un fenomeno estetico, ma prendere in carico i problemi, misurarsi con le ansie del proprio tempo, provare a dare risposte che replicano a domande. Quelle risposte per essere proficue e per segnare una crescita devono provocare nuove domande. Diversamente l’intellettuale è un predicatore. Uno che distribuisce catechismi. Un competente a libro paga.
Una roba da ideologi, o da agitatori. Un prodotto che nella storia è sempre stato molto diffuso. Il nostro tempo presente non fa eccezione.
 Maldonado durante la progettazione della macchina da scrivere elettrica “Tekne 3”
Maldonado durante la progettazione della macchina da scrivere elettrica “Tekne 3”
Dunque essere impegnati non voleva dire solo contribuire a costruire un’agenda pubblica di problemi, ma anche fare in modo che si formasse una nuova generazione di persone, non solo competenti, ma soprattutto sensibili.
L’intellettuale pubblico è questo, alla fine: una competenza professionale riconosciuta, ma anche la passione e la consapevolezza di pensarsi come anello di una lunga storia di generazioni che si protrae nel tempo e a cui lasciare dopo qualcosa che valga la pena esser portato avanti.
E tuttavia se abbiamo pensato di proporre e aprire un percorso di riflessione per il nostro tempo è perché quella sua storia di intelligenza applicata per noi non è solo quella di una storia di cultura, ma di un’inquietudine. Una storia che vorremmo provare a ripercorrere sinteticamente.
Le biografie culturali contano per il tempo in cui si collocano, ma poi contano soprattutto per ciò che testimoniano e per ciò che lasciano.
Anche per questo riteniamo che valga la pena spiegare in quale schema di «gioco grande» ci siamo collocati quando abbiamo pensato di avviare un laboratorio Tomas Maldonado. Per farlo crediamo che sia necessario collocarlo dentro un secolo che molti hanno pensato sia stato «breve» (da una parte Francis Fukuyama con il suo La fine della storia; dall’altra Eric J. Hobsbawm, con il suo The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991. Trent’anni dopo è facile dire che la storia non è finita o che il secolo non è stato breve).
Il primo dato da cui dobbiamo partire è che l’età degli estremi continua. Anzi per certi aspetti non è mai stata così «in salute». Forse, rispetto al ‘900, possiamo dire che ciò che è in crisi sia una idea di futuro. Ma questo è il segno di una crisi ben più profonda di cui né Fukuyama né Hobsbawm sono in grado né di fornirci un linguaggio, né di consegnarci un vocabolario. Ma il futuro non è mai stato scritto prima.
Dunque possiamo solo non smettere di indagare e di scavare perché saperne di più è una risorsa che aiuta a pensare domani (un errore sarebbe pensare che quel domani lo ci costruisce a casa propria, in forza della propria riflessione intellettuale).
Il tratto più rivoluzionario di Lukacs contro il pietre non è tanto in ciò che scrive, ma in ciò che fa. Quando le truppe dell’Armata rossa entrano a Budapest all’inizio del novembre 1956 per reprimere il tentativo riformatore del governo Imre Nagy, giunti al palazzo del governo, intimano ai membri del governo democratico di arrendersi e consegnare le proprie armi. Lukacs, che di quel governo è il ministro della cultura, fa un passo avanti e deposita sul tavolo la sua penna stilografica. Un intellettuale, dunque, è ciò che fa. E ciò che fa non è un sapere «a-priori».
Ma è le vie che intraprende per renderlo possibile. Non si tratta di costruire un’utopia come un cerchio perfetto, si tratta di sapere che per renderla reale inevitabilmente dovrà adattarsi e quella sfera tenderà ad assumere le forme di una palla da rugby o di un oggetto “storto”.
 Dettaglio dall’opuscolo informativo della scuola di design di ULM, dove Tomás Maldonado insegnò
Dettaglio dall’opuscolo informativo della scuola di design di ULM, dove Tomás Maldonado insegnò
Pensare «eterodosso»
Ma per raggiungere anche quel risultato modesto si tratta di sapere, ed ecco una terza lezione che ricaviamo da Maldonado: innovare significa sempre pensare «eterodosso». Perché il processo di spazio pubblico dell’intellettuale è essere scomodi rispetto al proprio tempo presente. E dunque il presupposto è non sdraiarsi sul “senso comune”, che vuol dire elogio del luogo comune, bensì guardare la realtà da un punto di vista diverso, comunque inquieto.
Per questo Maldonado riapre quel dossier su chi sia l’intellettuale, quale sia il suo ruolo, o quali rischi debba prendersi in carico se vuole esercitare quel ruolo, più che essere quello status.
Significa riprendere in mano le domande su cui nel corso del ‘900 quel tema aveva assunto la fisionomia per ripresentarsi in tutti i punti inquieti del secolo. Ovvero ripartire da Zola, ma poi soprattutto da Julinen Banda. Se la parola intellettuale, infatti, entra nel vocabolario, con la lettera aperta di Emile Zola (13 gennaio 1898) perché giustizia sia riconosciuta a Alfred Dreyfus, è poi Julien Benda, trent’anni dopo, a porre il tema bruciante dell’intellettuale pubblico.
Quando Julien Benda pubblica Il tradimento dei chierici, non pensa che quel titolo diventerà una metafora della politica. Il suo si potrebbe dire era un appello alla intransigenza. Assunto spesso più per il titolo che non per i contenuti che Benda proponeva; si potrebbe dire che il primo a tradire questa immagine del contenuto sia stato Benda stesso.
Nel 1946, a guerra conclusa, e dopo un decennio in cui non aveva mancato di schierarsi esplicitamente – compresa la convinzione di andare alla guerra, prima ancora che una parte consistente degli intellettuali francesi si dimettesse dal proprio pacifismo di principio, del tutto insoddisfatto dell’esito del Patto di Monaco che regala i Sudeti alla Germania di Hitler e sconcertato rispetto alla disponibilità ad accettare i soprusi del despota Hitler e dunque a regalare Danzica alla Germania nazista pur di non mettere in discussione la propria quotidianità (una condizione che la maggior parte dell’opinione pubblica francese aveva accolto invece con entusiasmo e non come una sconfitta) – Benda tornava a riprendere in mano quel testo che aveva pubblicato venti anni prima (nel 1927) e scrive
Il tema, in altre parole, era considerare l’impegno una vocazione in cui ciò che era in gioco non era predicare il vero, ma sforzarsi di dare forma al giusto.
Per farlo nella seconda metà del ‘900 in molte altre occasioni la questione di come preoccuparsi di correggere o di aiutare a individuare i luoghi delle storture per rendere meno storto il legno dell’umanità è stata una costante preoccupazione di quegli intellettuali pubblici e operativi che intendevano la loro competenza come luogo in cui contemporaneamente si provava a far progredire la consapevolezza pubblica, ma anche non venire meno alla costante pratica di fare un bilancio della propria funzione pubblica.
E così si trattava di mettere insieme lo stimolo morale di Benda, ma poi anche la visione caustica di Paul Nizan con il suo graffiante e impertinente Cani da guardia, con cui aveva invitato gli intellettuali a non accontentarsi di denunciare o di limitarsi a parlare. Poi si trattava di accompagnare un processo di crescita, di non fermarsi alla denuncia, ma di esserci.
Insieme, di fare molte altre cose. Per esempio: chiedersi come riprendere in mano il presente, dopo aver fatto propria la determinazione a ricominciare che Camus aveva proposto trasformando la metafora di Sisifo da sconfitto a «pervicace»; indicare che cosa era la funzione pubblica di intellettuale che provava a ricostruire predicata da Jean-Paul Sartre; fare propria la pratica dell’indagine nelle zone oscure del pensiero e delle pratiche si fare azione sociale intorno a cui Horkheimer e Adorno avevano scavato ripercorrendo la genealogia dell’antilluminismo o nelle pratiche che fondavano la personalità autoritaria.
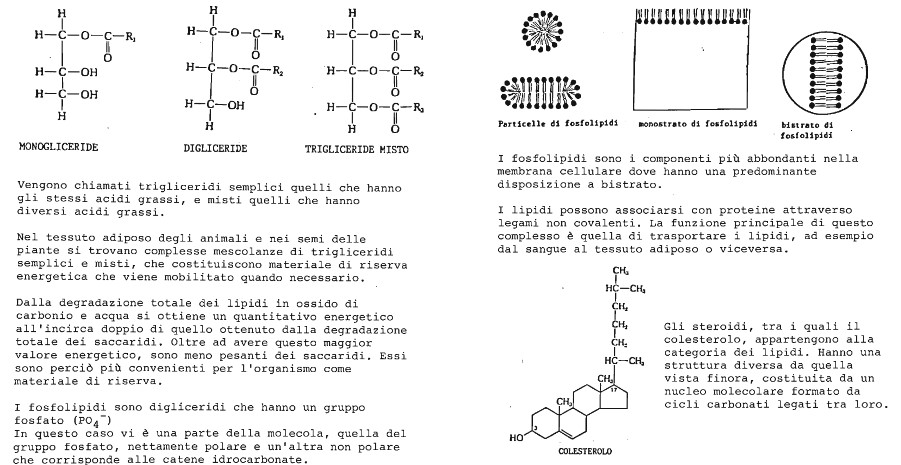 Dettaglio dalla dispensa per il corso di Progettazione Ambientale tenuto da Tomás Maldonado
Dettaglio dalla dispensa per il corso di Progettazione Ambientale tenuto da Tomás Maldonado
Oppure: cosa voleva dire ritrovare uno spazio pubblico e una memoria sociale dentro la città industriale che aveva attraversato la ricerca e le pratiche culturali di Maurice Halbwachs; favorire nell’agire pratico, e non come invocazione o come omelia l’incontro tra sapere scientifico e sapere umanistico che stava nell’impresa sociale di Adriano Olivetti.
Che cos’è un intellettuale?
Un profilo che negli stessi anni in cui Maldonado prova a fare un bilancio di una funzione pubblica con il suo Che cos’è un intellettuale? (Feltrinelli), stimola il laboratorio creativo di Zygmunt Bauman e muove l’inquietudine o l’intransigenza delle domande al potere alle sue macchine di persuasione e convinzione che animavano, per esempio, Noam Chomsky o Edward Said.
In breve: il mondo, l’insoddisfazione, del presente, la voglia di cercare un futuro, l’inquietudine per tentare di consegnare a una nuova generazione la voglia di costruirlo, con la consapevolezza che quella possibilità sta nel chiedere di «saperne» di più «di volerne sapere di più». Ovvero di non essere culturalmente autosufficienti, ma esigenti, e per questo anche un po’ insoddisfatti.
Il disincanto non era delusione era solo un modo per poter continuare, per non smettere.








