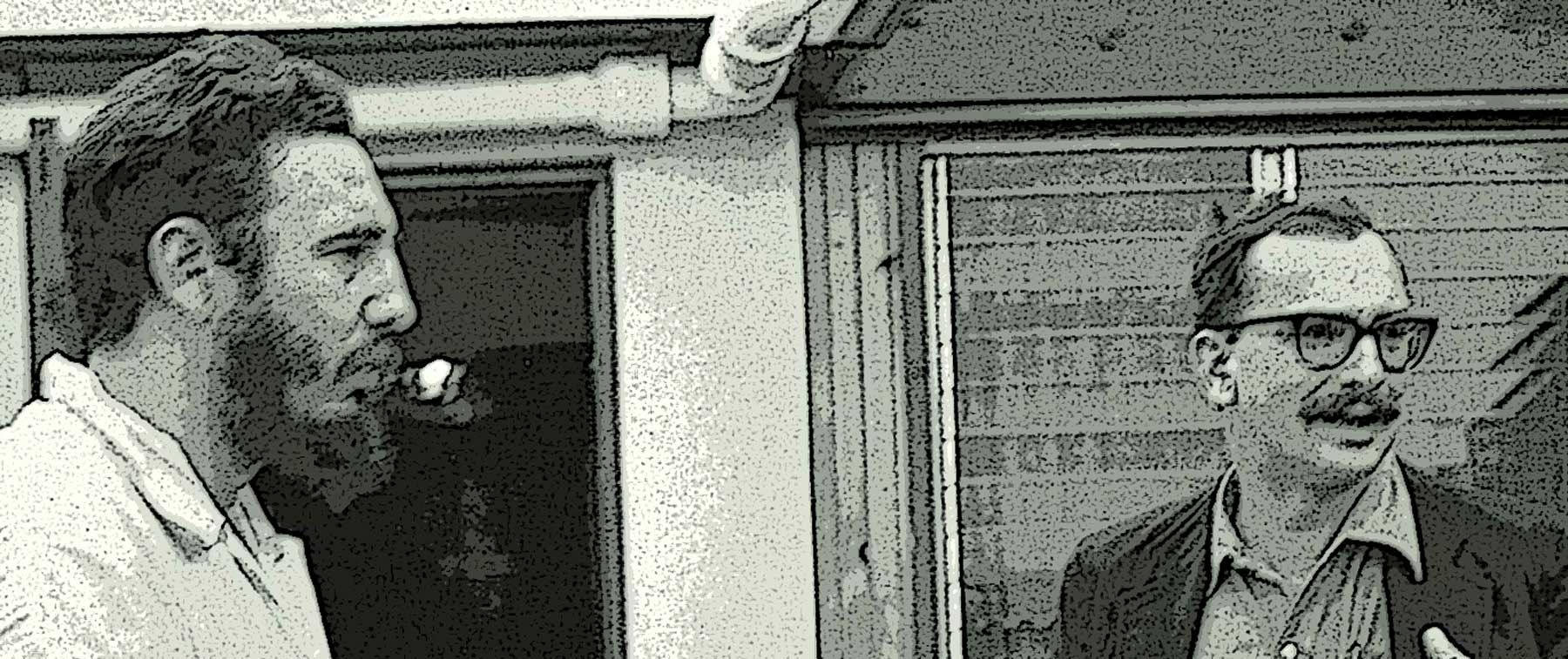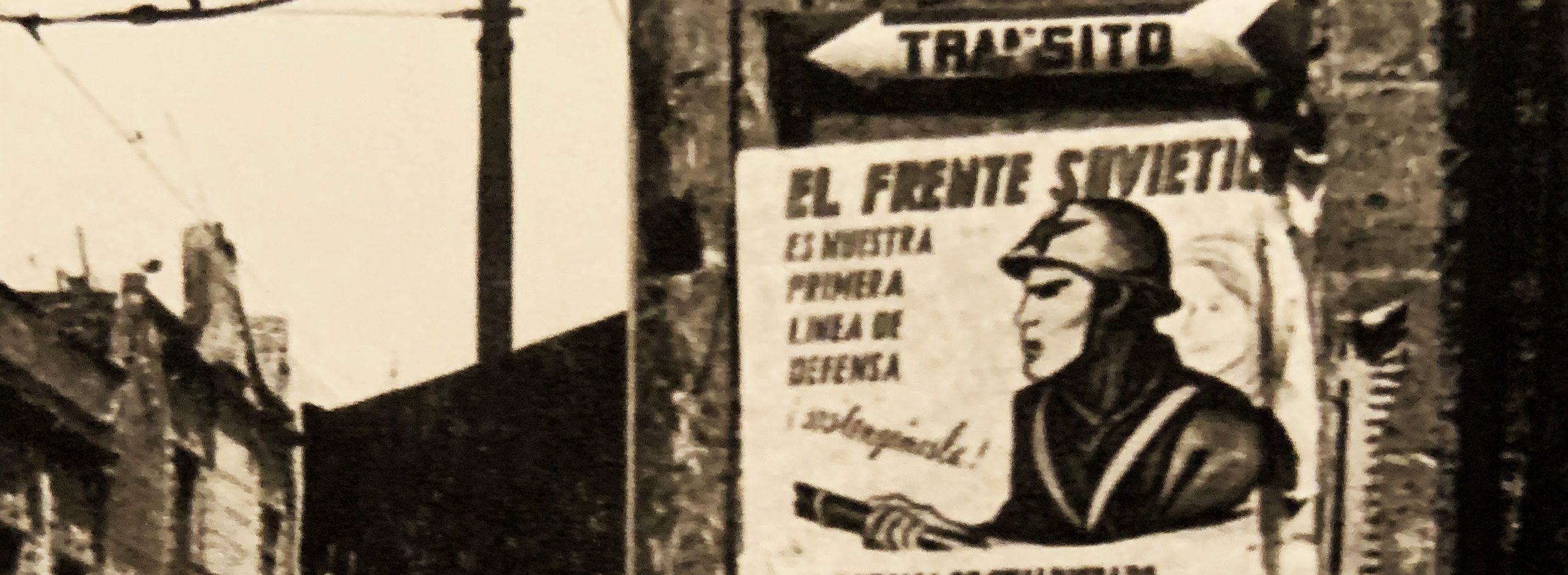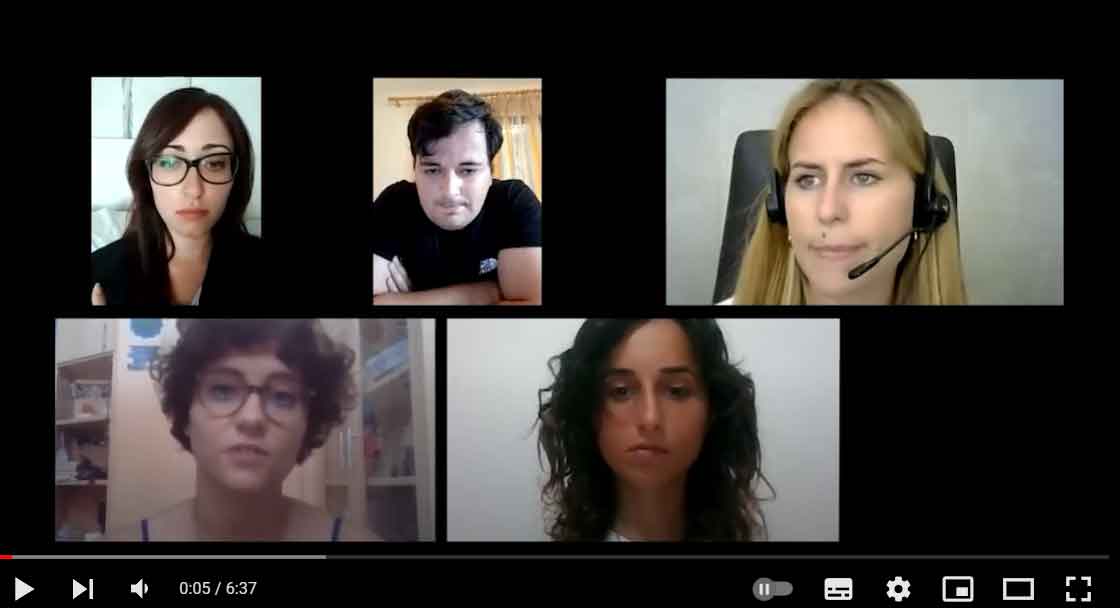La sfida del prossimo 25 aprile non sarà rivendicare un passato, ma provare a descrivere il futuro. È il paradigma diverso da quello che condusse centinaia di migliaia di persone in piazza il 25 aprile 1994 (il tema era che fare di fronte alla nascita del primo governo presieduto da Silvio Berlusconi).
Allora si trattava di rimpossessarsi di un 25 aprile che era entrato in crisi perché era finita la Prima repubblica dei partiti che lo avevano rappresentato. Ora si tratta di impostare una riflessione di futuro che prima di tutto deve fare i conti con una condizione differente: con una politica che si esprime come democrazia afascista, come hanno richiamato, efficacemente, Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà.
Non è una novità e del resto la storia del 25 aprile come ricorrenza in questi ottanta anni non è stata mai la stessa cosa. Ogni ciclo politico ha avuto il «suo 25 aprile».
Dunque, non si tratta di venir meno a un patto di memoria, ma costruire nuovi percorsi di memoria presente / passato / presente. Un percorso che non vive solo di uso politico del passato, ma anche di come si ricostruisce in sede storiografica la scena del passato. Un esempio per tutti: c’è un prima e un dopo Una guerra civile di Claudio Pavone. Non penso solo al complesso del libro, ma anche e soprattutto alle parole chiave che quel libro propone. Una su tutte: la scelta. Non avviene una volta sola, ma molte volte. Un atto che non sempre è una volta per tutte, ma è caratterizzato da percorsi avanti e indietro.
Ma rimaniamo al 25 aprile.
Forse si potrebbe cominciare dal darsi un appuntamento che non solo celebra la fine ma che apre anche alle cose da fare dopo. Ovvero una data bifronte: da una parte fornisce di parole e di gesti ciò che sta alla vigilia e poi trova gesti e parole distinti per ciò che si apre a valle di quel momento . Ovvero a evento consumato.
Nel primo caso il tema è vivere la vigilia – ovvero il momento in cui nella notte tra il 24 aprile e il «farsi alba» del 25 aprile si racconta «domani la liberazione». Nel secondo caso è provare ad affrontare quali «percorsi di libertà» intraprendere di fronte al bivio che la nuova condizione propone. Ovvero: quale agenda si apre?
Non è una distinzione capziosa. Liberazione e libertà ha suggerito Hannah Arendt tanti anni fa non sono la stessa cosa. E aggiunge: “la liberazione può essere una condizione della libertà, ma è assolutamente da escludere che vi conduca automaticamente” [p. 25].
«Domani liberazione» e «ora spazio alla libertà» non sono la stessa cosa. Nel primo caso prevale il sollievo di essersi scrollati di dosso un peso e dunque la prima cosa che si fa è festeggiare. Nel secondo caso si tratta di affrontare i nodi delle scelte che la nuova condizione di liberazione propone e obbliga a prendere. Qui prevale il senso delle responsabilità che si prendono.
Il primo caso è la scena di tutti i momenti in cui finisce il dominio e l’oppressione. Il secondo caso è la scena delle domande che si mettono sul tavolo, la voglia di scioglierle, gli impegni che si prendono e si sottoscrivono.
Nel primo caso si fa la narrazione della propria forza e la si elogia. Nel secondo si fa il bilancio delle proprie insufficienze, contraddizioni, illusioni perché la libertà non è mai il successo ma è la capacità di fare passi avanti condivisi con chi ha partecipato al processo di liberazione. Insieme è fare di tutto per includere chi stava dall’altra parte perché la libertà è quel percorso che deve consentire anche a quelli di cominciare una nuova possibilità rivedendo i propri errori.
Il problema non è né la clemenza né il perdono, né, all’opposto, l’intransigenza, ma la costruzione di un percorso politico culturale, emozionale capace di uscire dal codice deli linguaggi e dei vissuti totalitari.
Quel percorso per costruirlo, o almeno per avviarlo, deve mettere al centro come si ricrea patto.
Non ho una ricetta, ma credo che sarebbe interessante provare a confrontarsi con alcuni percorsi culturali che nell’immediato ultimo dopoguerra, almeno per noi qui (quello tra 1945 e inizio anni ’50) hanno provato a riflettere e a far riflettere sulle cose urgenti da fare per provare a ricominciare. Sono le questioni che animano le pagine di “Combat” tra 1944 e 1947 e che poi sono tornate più volte nella discussione pubblica per tutto il secondo dopoguerra.
La liberazione mette insieme i diversi in nome di un presente che non si vuole più. La libertà è il terreno in cui prevale il confronto tra progetti diversi e si tratta di «trovare la quadra».
Nel primo caso esplode l’entusiasmo. Nel secondo vince la forza degli argomenti, la visione di futuro, la capacità di mettere nel conto gli imprevisti, la disponibilità a discutere e fare compromessi. Ovvero pensare e muoversi per realizzare un percorso per domani, sapendo di dover mettere in discussione molte cose che hanno consentito l’atto di liberazione.