Cinque anni fa, il 15 marzo 2019, si tiene il primo sciopero climatico globale con una partecipazione di milioni di persone in tutto il mondo. Tutto ciò a meno di un anno dal primo presidio di Greta Thunberg di fronte alla sede del Parlamento svedese con in mano il cartello “Sciopero scolastico per il clima” e dal lancio sui social network dell’hashtag #fridaysforfuture, divenuto in poco tempo un fenomeno virale globale che porta in pochi mesi alla nascita dei primi gruppi locali di Fridays for Future.
Le radici storiche dello sciopero climatico
Nonostante i suoi caratteri peculiari e la sua grande capacità di mobilitazione, almeno fino alla pausa forzata della pandemia/sindemia, il Global Strike for Climate non è però certamente la prima mobilitazione di massa sulla questione climatica. Anzi possiamo dire si tratti in un certo qual modo della terza ondata del movimento per il clima, dopo la prima ondata tra il 2006 e il 2009 culminata nelle mobilitazioni per la COP15 di Copenaghen e la seconda ondata negli Stati Uniti nel 2011 contro l’oleodotto Keystone XL. Ma potremmo in realtà risalire ancora più indietro, ad esempio al 1992 quando a Rio de Janeiro si svolge il controvertice al Summit della Terra, tappa fondamentale per quello che sarà il movimento No Global.
Se invece l’analisi si estendesse ai movimenti ecologisti in senso ampio allora bisognerebbe tornare indietro di qualche decennio, ai primi movimenti ecologisti sviluppatisi negli anni ’70 soprattutto in seguito ad alcuni gravi disastri ambientali (in Italia prima di tutto quello di Seveso del 10 luglio 1976). Nello stesso periodo il termine ecologia diventa a tutti gli effetti di uso pubblico e inizia a svilupparsi una diffusa coscienza ambientale già fortemente stimolata dalla pubblicazione di Primavera silenziosa, un testo fondamentale del 1962 della biologa statunitense Rachel Carson (1907-1964) in cui la denuncia dell’uso dei pesticidi in agricoltura, in particolare del nefasto DDT, è accompagnata da accenni ai nuovi diritti in ambito ambientale che avranno ampia eco negli anni successivi.
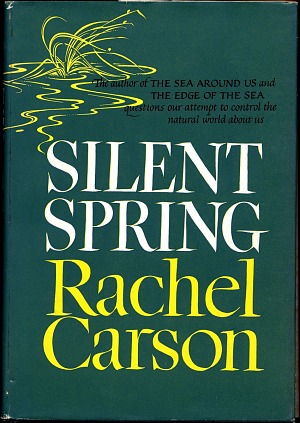
“Silent Spring”, Rachel Carson, 1962
Cambiamento di paradigma
Nel 1972 poi la ricerca commissionata dal Club di Roma a un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston fornisce una descrizione dettagliata della situazione del pianeta e individua, per la prima volta in uno studio scientifico, la crescita economica come la principale causa dei problemi ambientali tra cui l’inquinamento, l’esaurirsi delle risorse e la distruzione degli ecosistemi. Giudicando probabile un’imminente catastrofe ecologica, gli autori del rapporto I limiti dello sviluppo propongono alcune soluzioni pratiche di tipo globale arrivando ad auspicare una politica di “non crescita” o di “crescita zero” che susciterà numerosi dibattiti.
Se infatti i grandi poteri politici ed economici non mostreranno mai nella pratica un’adozione neppure parziale di tale suggerimento, vi saranno autori tra cui l’economista e filosofo francese Serge Latouche (Vannes, 1940) che porteranno tale suggestione alle sue evidenti conseguenze arrivando a teorizzare una politica della Decrescita felice, concretizzatasi in un movimento transnazionale che propone un cambiamento di paradigma valoriale e culturale a livello personale, collettivo, politico e sistemico per uscire da una logica economica di crescita illimitata.
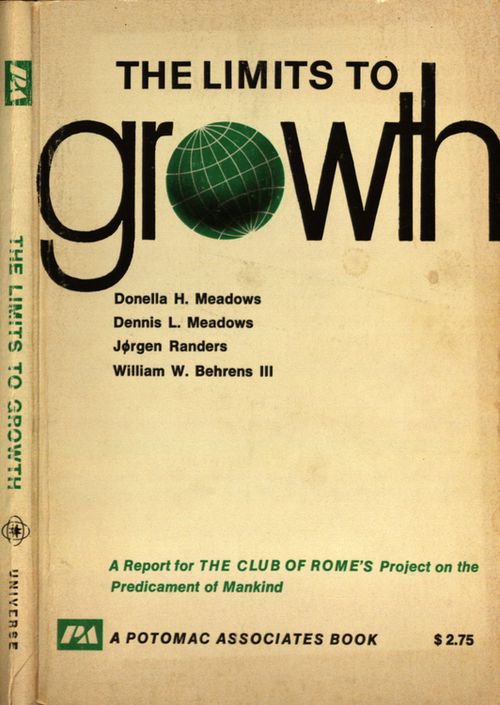
“The Limits to Growth”, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
La disillusione dei movimenti
Se i movimenti giovanili per il clima degli ultimi anni inizialmente sembrano adottare una politica di semplice richiesta di mitigazione del danno, recentemente stanno invece mostrando una radicale e profonda consapevolezza che quella climatica è una crisi sociale e che non è più possibile credere a una transizione ecologica dall’alto. I nuovi movimenti dimostrano oggi di aver preso atto del fallimento dell’idea che i governi possano risolvere la crisi climatica, denunciando l’inerzia di trattati come quello di Kyoto o di Parigi o l’inutilità degli impegni non vincolanti presi nelle varie conferenze internazionali per il clima. Preoccupati dall’emergenza climatica, non credono in gran parte più al famoso “sviluppo sostenibile” o alla cosiddetta green economy, rivelatisi un’inedita opportunità di profitto senza compiere azioni radicali e sostanziali per alterare il corso della crisi climatica.
L’intreccio tra questione sociale e questione ecologica
Gli odierni movimenti ecologisti, avendo compreso la natura politica e sistemica della crisi climatica, stanno costruendo relazioni e creando intersezioni con altre forme di lotta basate sul principio della giustizia sociale nella convinzione dell’intreccio indissolubile tra questione sociale e questione ecologica.
Tale concetto non è nuovo nella storia del pensiero ecologista. Già dagli anni ’60 Murray Bookchin (1921-2006) scriveva che la questione ecologica è inscindibile dalla questione sociale e che l’unica soluzione possibile all’imminente disastro ecologico è la trasformazione radicale della società in senso libertario, eliminando il dominio di un essere umano sull’altro e cancellando il principio stesso della dominazione.
Non a caso il pensiero politico di Bookchin – l’ecologia sociale – sembra godere di una nuova riscoperta grazie anche alla crescente consapevolezza della stretta correlazione tra cambiamenti climatici e dissesti sociali. Bookchin d’altronde non è stato semplicemente uno dei pionieri del movimento ecologista, denunciando la comparsa all’orizzonte di una grave crisi ecologica già dal 1952, ma è stato anche uno dei pensatori politici radicali più originali della seconda metà del ’900, influenzando tra gli altri anche Abdullah Öcalan e il progetto di confederalismo democratico in Rojava.
Giustizia ambientale e giustizia sociale
L’originalità del pensiero bookchiniano consiste proprio nell’affermare il legame tra giustizia ambientale e giustizia sociale, individuando la causa della crisi ecologica nella rottura dell’equilibrio tra esseri umani e tra umani e natura provocata dall’emergere della logica del dominio. Da qui l’affermazione di Bookchin della necessità di una trasformazione radicale della società attraverso la costruzione di quella che chiama una “società ecologica”, ovvero una società orientata in senso libertario, non gerarchica, senza classi, con un’etica del mutuo appoggio e basata su assemblee popolari in un’autentica radicale democrazia diretta.
Ritenendo il sistema capitalistico antiecologico per definizione e il sistema gerarchico intrinsecamente incompatibile con il ristabilimento di un rapporto armonioso tra esseri umani ed ecosistema, Bookchin auspica il completo smantellamento dell’attuale sistema politico ed economico fin dalle sue fondamenta, in tutte le sue espressioni gerarchiche, per sostituirlo con rapporti sociali totalmente differenti, basati sulla reciprocità della cura e il mutuo appoggio di kropotkiniana memoria.
Ecofemminismo
Si tratta di una visione che risuona anche in un altro significativo percorso teorico e pratico sviluppatosi a partire dagli anni ’70 in cui femminismo ed ecologia trovano connessioni profonde. L’espressione ecofemminismo viene coniata dalla scrittrice francese Françoise d’Eaubonne nel 1974 ne Il femminismo o la morte, testo in cui l’autrice invita le donne a dare inizio ad una rivoluzione ecologica giudicata necessaria per salvare il pianeta.
Il concetto di ecofemminismo riceverà in seguito molte elaborazioni teoriche, tanto che sarebbe più corretto parlare di ecofemminismi, divenendo nel 1980 un vero e proprio movimento a partire dalla conferenza Donne e vita sulla terra: l’ecofemminismo negli anni Ottanta, a cui seguirà una grande manifestazione di donne contro la guerra e gli armamenti nucleari davanti al Pentagono. Al momento si assiste a una rinascita dei movimenti ecofemministi e transfemministi in tutto il mondo che propongono, in risposta alla crisi climatica, modelli e pratiche di cooperazione con l’obiettivo di costruire società egualitarie, libere dalla subordinazione di genere, di classe e di razza.

Convergere verso l’impossibile
Accanto a ciò, il movimento decoloniale e il pensiero antispecista radicale stanno fornendo utili strumenti per un’ulteriore comprensione della connessione tra crisi ecologica e crisi sociale, evidenziando i complessi legami tra le varie forme di oppressione.
Oggi, di fronte all’aggravarsi della situazione ecologica, mentre emergono nuove forme di attivismo, tra cui in particolare forme di disobbedienza civile, sembra finalmente concretizzarsi una convergenza delle lotte dei movimenti ecologisti con i movimenti decoloniali, transfemministi, di classe e antispecisti, nella consapevolezza sempre più diffusa che non può esserci giustizia climatica senza giustizia sociale e quindi senza lotta al colonialismo, al patriarcato, alla disuguaglianza economica e sociale, al razzismo, all’abilismo, allo specismo, e a tutte le oppressioni sotto qualsiasi forma si manifestino.
Invece che lasciarsi travolgere dall’ecoansia o farsi sopraffare dal catastrofismo, gli attuali movimenti radicali sembra stiano iniziando a sperimentare metodologie e pratiche diverse da quelle in cui siamo immersi, recuperando alcuni degli strumenti proposti nella storia del pensiero ecologista radicale come la costruzione di relazioni orizzontali, assemblee popolari, forme autentiche di democrazia diretta, costruzione di reti solidali, visioni circolari e pensiero utopico. D’altronde, come scriveva il già citato Bookchin, “se non faremo l’impossibile ci troveremo di fronte l’impensabile”.








