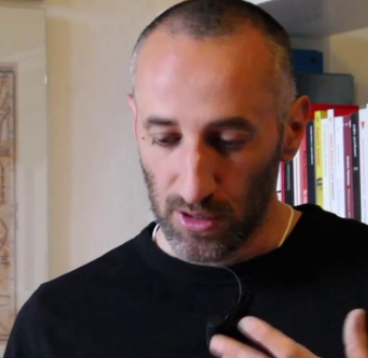Ho passato gran parte della mia vita in università, prima come studente, poi come dottorando, infine per lavoro. L’impressione che ho avuto alcuni giorni fa, uscendo dalla lezione che avevo appena terminato di fare, e ritrovandomi al cospetto di una cinquantina di studenti con striscioni e bandiere da un lato, e di un gruppo di qualche decina di agenti in borghese dall’altra, è stata di un’università che non è più un’università. Che non è più un luogo perché non ha più una sua “anima” ed alcuna reale autonomia. È anche per questo motivo, forse, che oggi il secondo ateneo più grande d’Italia è un’università telematica…
Però, questa, è una storia che bisogna riprendere tornando un pochino più indietro.
Dal periodo fascista alla saldatura con il mondo del lavoro
Molti degli studenti e studiosi che nel maggio 1936 erano in piazza ad applaudire vertiginosamente alla proclamazione dell’Impero, o che avevano partecipato ai Littoriali della cultura, avevano presto perso quegli entusiasmi, perché molta acqua era passata rapidissima sotto i ponti.
C’era stato l’anno guerraiolo del 1938, l’intervento nella Guerra civile spagnola, le leggi razziali, l’Asse Roma-Berlino… e molti di quelli erano diventati antifascisti, partigiani, organizzatori della Resistenza, padri costituenti.
È anche nella capacità di produrre pensiero dell’università – seppur fascista – che un’intera generazione di giovani studenti e studiosi si era separata appunto da un fascismo in cui non credeva più, saldandosi poi con i grandi scioperi operai del marzo 1943.
L’Università, in Italia, ha sempre avuto un ruolo centrale non solo nell’analisi della società, è ovvio, ma anche nel cristallizzare, anticipare e in qualche modo “incubare” grandi trasformazioni istituzionali e epocali del nostro paese.
Molti anni dopo, negli scontri contro il governo Tambroni nel 1960, o nei fatti di Piazza Statuto del 1962, di nuovo si vide l’impatto delle trasformazioni sociali avere a sua volta un impatto rilevante su un’intera generazione di studenti. Con il lento ingresso della classe operaia nell’università italiana – agevolata anche dalla riforma della scuola media del 1962, e dunque dagli scontri di quegli anni – si preparava la stagione della Contestazione e della saldatura fra università e mondo del lavoro. L’Università non ha, da allora e per molto tempo, mai più smesso di essere un luogo “in cui succedevano cose”.
Gli anni dei movimenti
Una stagione che simbolicamente possiamo fare finire il 7 aprile del 1979, con gli arresti e la caccia alle streghe dentro all’Università, a cominciare da Padova, fra presunti “cattivi maestri” e presunti “pessimi allievi”. E negli anni ’80 furono varate alcune importanti riforme, tra cui l’istituzione dei dipartimenti universitari, ma soprattutto, con la legge 9 maggio 1989, n. 168, l’autonomia organizzativa, didattica, finanziaria degli atenei.
L’Università che chi scrive ha conosciuto, verso la fine degli anni Novanta, era evidentemente figlia del movimento della Pantera, che aveva spezzato e posto fine al riflusso degli anni Ottanta, riportando la politica nelle aule e nei chiostri e tornando a fare dell’Università quella sorta di “villaggio globale” che era al tempo stesso un luogo di passaggio ed un posto sicuro, nel quale potevano quotidianamente incontrarsi militanti e studenti, cittadini attivi politicamente e giovani più o meno alla ricerca di sé. La prassi voleva che i Rettori non concedessero l’ingresso alle forze dell’ordine, così il villaggio globale si conservava variegato, libero, capace di produrre pensiero, più o meno elevato che fosse. E poi incontri, riunioni, assemblee, molta spontaneità e soprattutto un enorme scambio di parole.

Le riforme e la trasformazione dell’Università
E così, nella prima metà degli anni Novanta venne istituito il Fondo di finanziamento ordinario e nella seconda parte del decennio giunse un ulteriore forte impulso alla trasformazione dell’università con le leggi Bassanini, che aumentarono l’autonomia funzionale degli atenei. Tra i vari aspetti, la riforma rimodellava i corsi di studio, introducendo la cosiddetta formula del 3+2, che ulteriormente omologava i percorsi di studio a livello nazionale. Veniva inoltre introdotto il credito formativo universitario (CFU), ossia una modalità utilizzata nelle università per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente per il conseguimento di un diploma di laurea. Ciò che senz’altro diminuì ampiamente il carico di studio per gli studenti.
In quella fase storica, si fece strada il dibattito sui tornelli all’ingresso delle università, per rispondere all’urgenza di “tenere fuori” gli estranei dagli atenei. In alcuni luoghi furono istituiti, in altri no, ma quel che contava era che si affermasse l’idea che in università dovessero starci soltanto gli studenti pagatori di tasse. Che l’università non fosse più un luogo di bivacco, ma nemmeno di scambio, di confronto, di porosità fra la società civile e il “mondo di dentro”. Che non fosse più un luogo sociale e politico, dove la polizia potesse ormai entrare, e in modo residenziale potesse farlo la vigilanza privata, ma un militante politico, insomma, era ormai meglio di no.
Luoghi di solitudine politica
Si “muove” così poca politica, oggi, dentro alle università, che con la cosiddetta “terza missione” si è addirittura stabilito che l’impegno civico, civile e politico dei professori si debba anche quello svolgere fuori, in istituzioni culturali che non siano le università.
L’università italiana, a partire dagli anni 2000, ha in effetti conosciuto un ulteriore radicale processo di cambiamento, dapprima con la normazione delle università telematiche e, successivamente, con la riforma Moratti prima e quella Gelmini poi. La legge 6 agosto 2008, n. 133 diede alle università la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, aprendo alla privatizzazione degli atenei.
Forse è anche per questo che l’università, oggi, appare come un grande laboratorio di solitudini, di precarietà professionale, di abbassamento della qualità dell’insegnamento impartito, di riduzione drastica del diritto allo studio. Forse è anche per questo, dicevamo, che l’Università è in crisi al cospetto delle più convenienti università telematiche, il non-luogo forse per definizione, totale, assoluto, eppure così attuale, contemporaneo, in un villaggio globale che del villaggio non ha davvero più niente.