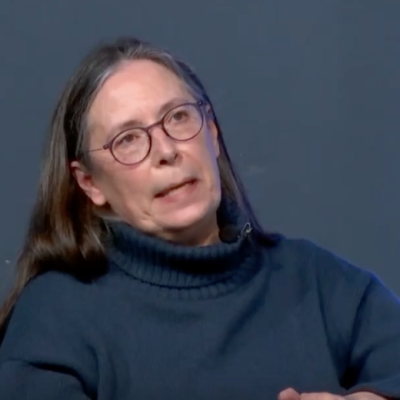L’impulso a distruggere i manufatti commemorativi di un regime percepito come oppressivo e dal quale si vuole prendere commiato il più rapidamente possibile ha segnato in modo profondo il processo di liberazione dello spazio pubblico nei paesi dell’Europa orientale a partire dal 1989. La folla, come già sovente nel corso del tempo, si è gettata su statue e sculture come se fossero persone in carne ed ossa, rivolgendovi contro quell’energia eccedente che può sì indirizzarsi verso il corpo che l’ha accumulata, ma può anche rivolgersi ad un ambiente pieno di segni che richiamano alla mente il passato: “Nella vita di ogni essere (specie, individuo o gruppo) – scriveva Henri Lefebvre in La production de l’espace (1974) – ci sono dei momenti in cui l’energia disponibile, sovrabbondante, tende ad esplodere. Essa può rivolgersi contro se stessa, oppure verso l’esterno, in modo gratuito e gratificante”.
Il trasferimento del Soldato di bronzo a Tallin
I memoriali di guerra eretti per celebrare le vittorie dell’Armata rossa durante il secondo conflitto mondiale, talvolta posti in luoghi destinati alla sepoltura dei caduti, sono stati oggetto di ricorrenti distruzioni o rimozioni. Nell’aprile del 2007, a Tallin, viene sottratto alla pubblica riverenza il cosiddetto Pronkssõdur [Soldato di bronzo], innalzato nel 1947 per onorare la liberazione dell’Estonia dall’occupazione tedesca.
La decisione di trasferire il monumento dalla collina di Tõnismäe, nel cuore della capitale, al cimitero militare cittadino produsse gravi disordini per opera della minoranza di lingua russa (un terzo della popolazione estone), attivamente sostenuta dai propri rappresentanti politici i quali, parlando di un gesto che riabilitava il nazismo, provocarono una crisi delle relazioni diplomatiche tra Estonia e Federazione russa.
Il Soldato di bronzo era la Storia che, perduta la malleabilità espressa nella pluralità dei documenti, si era trasferita in un materiale indeformabile: il Monumento. Poteva restare al suo posto – solenne e maestoso – fintanto che l’Avvenimento (la liberazione del territorio estone ad opera dell’Armata rossa) fosse percepito da chi lo guardava in modo distaccato dagli avvenimenti precedenti e seguenti il conflitto. Ma, a partire dal momento in cui i cittadini dell’Estonia indipendente (1991) iniziarono a decostruire il modello fuso nella statua, il Soldato di bronzo, secondo quanto esige la retorica della memoria nazionale, non poteva più stare là dove era stato collocato: risultava, letteralmente, fuori luogo, perché la società civile percepiva ormai quel soldato “liberatore” come un soldato “oppressore”. L’Unione sovietica aveva infatti, il 21 luglio 1940, messo fine all’indipendenza estone e, dopo la sconfitta della Germania, non aveva rinunciato al piano di spartizione dell’Europa sancito dagli accordi segreti del patto Molotov-Ribbentrop.
La rimozione dei Monumenti della gratitudine a Varsavia
Anche in Polonia viene avviata, nei primi anni ’90, una campagna di opinione pubblica per rimuovere i Pomniki wdzięczności [Monumenti della gratitudine], eretti con lo scopo di celebrare la liberazione dei territori occupati di cui era stata protagonista l’Armata rossa nella sua avanzata verso Berlino. Qui la questione era resa ancor più delicata dal fatto che questi memoriali erano stati talvolta innalzati in luoghi destinati alla inumazione dei caduti.
In sostanza, le sempre più frequenti vandalizzazioni violavano la protezione internazionale accordata ad alcuni siti di sepoltura e confliggevano con gli accordi bilaterali di tutela delle salme.
Ad esempio, il monumento della “gratitudine” eretto, nel 1946, nel Parco Skaryszewski di Varsavia era stato collocato sopra la sepoltura di ventisei soldati sovietici, uccisi durante violenti combattimenti nel settembre del 1944. Ma le loro salme erano già state riesumate e trasferite durante lavori di manutenzione condotti nel 1968. Il monumento è stato definitivamente distrutto nel 2018, malgrado le proteste delle autorità russe.
Particolarmente controversa per i rapporti bilaterali è stata la decisione delle autorità municipali di Praga di rimuovere, il 3 aprile 2020, dopo un intenso dibattito pubblico, la statua eretta nel 1980 in onore del generale sovietico Ivan S. Konev, a capo delle divisioni dell’esercito che liberarono Praga dall’occupazione nazista, ma anche responsabile delle repressioni della Rivoluzione ungherese e della Primavera di Praga. Per non parlare dello smantellamento del monumento ai soldati sovietici collocato a Riga – un provvedimento approvato nella primavera del 2022, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, a seguito del quale la Lettonia ha ritirato la sua adesione ad un accordo con la Russia riguardo alla conservazione dei monumenti ai caduti d altri segni commemorativi.
Distruzione e reinterpretazione dei monumenti sovietici nella transizione verso la democrazia
L’esperienza di liberazione dello spazio comunista invita a riflettere sulla complessità dei fenomeni iconoclastici e impone in particolare di misurarne frequenza e radicalità, così come di distinguere tra rimozione, distruzione, vandalismo, modificazione, reinterpretazione, decadimento per negligenza e, persino, sovraiscrizione, come dimostra ancora oggi la presenza diffusa di “piedistalli vuoti”, specifica forma di oggetti sovrascritti o meglio “sotto iscrizione” (sous rature – secondo l’espressione di Jacques Derrida): vecchi segni fatti sopravvivere in attesa dei nuovi, testimonianza di una scrittura che scompare pur rimanendo leggibile, né veramente presente né del tutto assente, marcatore di una memoria allusiva e, al tempo stesso, trasparente.
È anche una esperienza che impone di riflettere sulle differenze tra Paesi, nel quadro di disomogenee transizioni verso la democrazia; di distinguere tra campagne coordinate a livello centrale, promosse per iniziativa di autorità locali o nate su pressione di “folla”; di valutare con attenzione la tipologia dei manufatti (in particolare, statue o memoriali di guerra), a volte simili nello stile ma il cui destino dipende molto da visioni contestate o concorrenziali della storia e, al tempo stesso, le orienta; di determinare il peso delle specificità nazionali su iconoclastia, vandalismo o distruzione sporadica.
D’altro canto, artisti e movimenti d’avanguardia hanno creato un imponente archivio di reperti, sperimentazioni e riflessioni, ancora da valutare in tutte le sue potenzialità. Il ripensamento performativo ha compreso sia azioni-performances concrete, sia pratiche che non rivendicavano l’arte, ma vi erano molte vicine, così come forme artistiche sovversive. L’obiettivo è stato di favorire una nuova percezione degli eroi del passato, desacralizzandoli e facendo loro parlare la lingua del presente: i monumenti, più che essere distrutti o conservati, andrebbero dunque alterati e risignificati in modo da rendere ancora più visibile una cesura.
Si pensi a A Szabadság Lelkének Szobra [Il Fantasma della Statua della Libertà] di Tamás Szentjóby, modello d’installazione realizzato a Budapest (1992), che presentava la Statua della libertà – memoriale della liberazione sovietica nel 1945 – coperta per cinque giorni da un drappeggio bianco a significare la transizione democratica.
È solo un esempio di come il rapporto tra iconoclastia e creatività sia diventato una delle principali questioni dopo il 1989, quando i cambiamenti di regime accompagnati da una massiccia cancellazione, distruzione o alterazione d’immagini, hanno anche acquisito una dimensione propositiva.
La strategia principale di simili azioni – come già anticipava Krzysztof Wodiczko nelle sue note sulle procedure di “proiezione” (1986) – è stata quella di “attaccare il memoriale di sorpresa”: nessun proposito di rianimarlo o di promuoverne una “socializzazione” acritica e burocratica, ma piuttosto di pervertirne la funzione ed esporne al pubblico la caducità. Quale più efficace gesto iconoclasta, se non quello d’intervenire contro la “vita immaginaria” del memoriale stesso e contro l’idea di una coesistenza col memoriale in forma di “abbandono passivo”?