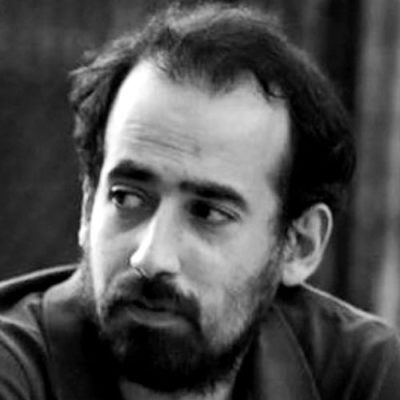Lotte collettive: da La Perla di Bologna all’ex Gkn di Campi Bisenzio
Il presidio permanente degli operai della fabbrica ex Gkn Driveline di Campi Bisenzio, per reindustrializzare nonostante i piani del nuovo proprietario. Gli scioperi lanciati dal Sindacato Unione Democrazia Dignità (Sudd Cobas), per sindacalizzare coloro che erano considerati fino a poco tempo fa insidacalizzabili, ovvero gli operai migranti del distretto tessile più grande d’Europa, in Toscana, nei cui capannoni il sindacato sembrava non potesse entrare. La mobilitazione delle lavoratrici de La Perla di Bologna, per salvare e rilanciare un marchio storico della moda scarnificato dalla speculazione finanziaria. E Mondeggi Bene Comune, a Bagno a Ripoli, a ridosso di Firenze, la fattoria occupata da oltre 10 anni per difendere ettari di patrimonio pubblico abbandonato promuovendo un modello di autogestione, focalizzato sull’agricoltura contadina e l’agroecologia, con centinaia di persone provenienti dai comuni limitrofi che partecipano attivamente al progetto.
Queste lotte per il lavoro hanno coagulato intorno a loro anche altre vertenze, collettivi, associazioni, movimenti, istituzioni culturali, docenti, ricercatori, studenti, intellettuali e semplici individui che forniscono quotidianamente nuovi impulsi, orizzonti da perlustrare che vadano oltre la questione sindacale. La concatenazione delle idee di chi partecipa a questi processi permette di immaginare nuove convergenze.
Oltre ad avere una natura resistenziale – scongiurare i licenziamenti, rivendicare condizioni di lavoro eque e dignitose, restituire un bene comune alla collettività – queste esperienze si configurano come atti trasformativi della realtà: la loro prassi immagina e mette in pratica un futuro alternativo, realizzabile perché frutto di un’analisi delle condizioni materiali che caratterizzano il presente.
Futura Umanità è un podcast prodotto da IrpiMedia (quattro puntate in uscita una volta a settimana, dal 3 maggio) che racconta le storie di queste e altre esperienze. Presenti e passate con le testimonianze tratte da Ruvide, storie di lotte e lavoro, l’archivio audiovisivo dello Spi-Cgil sul movimento operaio italiano tra gli anni ‘50 e ‘80, curato dal centro di giornalismo permanente (Cgp).
Perché una testata come IrpiMedia, che ha costruito una reputazione nel contesto editoriale principalmente grazie alle inchieste, si è dedicata alle alternative che stanno ancora cercando di avverarsi invece che ai “soliti” fatti? Perché dentro queste vicende si cela un’idea partecipata di futuro da contrapporre a chi vorrebbe dismettere, cancellare e liquidare. Sono tracce di “giornalismo delle soluzioni”, quello che invece di concentrarsi sui problemi cerca delle risposte. Anche quando non ci sono.
Ri-significhiamo tutto!
Alcune pratiche di queste esperienze potrebbero diventare strumenti replicabili in altri contesti. Come lo sciopero promosso dal Sudd Cobas lo scorso autunno nel distretto tessile di Prato con cui sono stati siglati gli accordi contrattuali 8X5: otto ore di lavoro per cinque giorni alla settimana in nove fabbriche dove gli operai erano privi di tutele e costretti a ritmi massacranti, dodici ore per sette giorni.
Lo strike day, il giorno dello sciopero, non solo pretendeva condizioni regolari ma rimodulava la pratica dell’astensione dal lavoro: il picchetto, il blocco davanti ai capannoni, diventava un punto di intersezione materiale delle diverse soggettività che si riconoscono nella lotta degli operai del tessile. E che accorrevano per dare manforte, supporto logistico e sostegno alla loro battaglia. Così le conoscenze acquisite tramite la lotta, gli aneddoti sulle condizioni di fabbrica, le strategie da attuare in altri contesti vertenziali hanno iniziato a circolare tra i lavoratori nei piazzali del macrolotto di Prato.
Nell’ex Gkn, il collettivo di fabbrica è una degli architravi su cui si poggia la vertenza: nato per essere un livello intermedio di rappresentanza tra la Rsu e l’assemblea dei lavoratori, riprende “le esperienze scaturite negli anni ‘70, quelle dei Consigli di fabbrica, prendendo spunto anche dalla Flm”, spiega Matteo Moretti, delegato sindacale e membro del collettivo. Il riferimento è alla Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm), l’esperimento del sindacato unitario nato nel 1972 e tramontato poi nel 1984. “Quella che noi chiamiamo convergenza, la praticavamo già prima”, sottolinea. Il collettivo di fabbrica, infatti, si riuniva periodicamente con i lavoratori delle cooperative in appalto e dei precari che vorticavano nello stabilimento di Campi Bisenzio. “Ascoltavamo le loro necessità e poi stilavamo insieme un documento unitario di rivendicazioni da sottoporre alla direzione aziendale”.
L’obiettivo, già da allora, era pensare a un modo diverso di essere fabbrica. All’inizio erano le rivendicazioni dei lavoratori: la loro unità oltrepassava le differenze contrattuali fornendo linfa vitale e capillarità all’azione sindacale. “Riuscivamo a convergere in un’unica piattaforma e arrivavamo più facilmente all’obiettivo che ci eravamo prefissati”, continua Moretti. Oggi è l’idea di una “fabbrica pubblica e socialmente integrata”, da portare avanti nonostante i licenziamenti e i piani per una speculazione immobiliare.
Futura umanità
Futura Umanità è un podcast realizzato con il contributo alle ricerche di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Il titolo della prima puntata è La finestra sul cortile e raccoglie tutta una serie di incipit che verranno poi sviluppati nelle puntate successive: il perché di questo podcast, il perché siamo noi a scriverlo, le utopie, la loro storia e i nessi tra passato e presente. Nella seconda puntata, Odio mosso d’amore, le testimonianze dei lavoratori e delle lavoratrici sfruttati saranno centrali. In Tifiamo rivolta, invece, saranno le pratiche di lotta, gli scioperi e le manifestazioni ad essere protagonisti. Infine, nell’ultima puntata, Sogni d’oro, le ipotesi di futuro prenderanno forma. Ogni puntata verrà introdotta dalla storia di Claudio, mio padre, che ha sempre sognato a occhi aperti finché ha potuto.