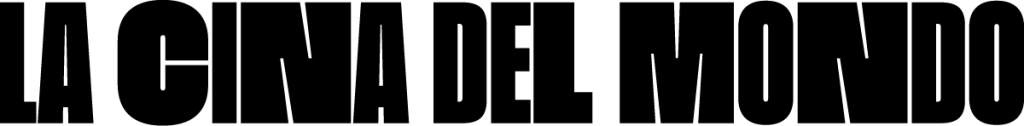Esiste un modo di produrre che si serve dei capitalisti, per amministrarli. È la Cina di Xi jinping, che stabilisce obiettivi politici attraverso la pianificazione economica. A partire dagli anni ‘70 il sistema economico di Pechino è passato da un’economia emergente fino a diventare il gigante tecnologico e leader nel settore delle auto elettriche e della manifattura, primo esportatore mondiale di beni. Come ha fatto? Nella ricetta del “capitalismo amministrato” cinese, c’è una risorsa chiave: la programmazione e la competizione interna delle imprese
Il “socialismo con caratteristiche cinesi” è spesso considerato sbrigativamente come etichetta ideologica.
In realtà il termine descrive un modello economico costruito dalla Cina in più di quarant’anni, che combina direzione politica centrale e competizione di mercato come strumenti coordinati.
La Cina a metà tra capitalismo e pianificazione
La Cina oggi è uno snodo sistemico dell’economia mondiale: in termini di parità di potere d’acquisto è il principale contributore al pil globale, e a prezzi correnti è continuato a crescere attorno al 5% nel 2024, pur su un sentiero di rallentamento strutturale.
È il primo esportatore mondiale di beni, con circa il 14,6% dell’export globale di merci nel 2024. Il peso manifatturiero rimane decisivo nelle filiere internazionali dell’elettronica, dei macchinari, dei veicoli elettrici e delle batterie.
Parallelamente, il Paese progredisce su tecnologia e autonomia industriale: la spesa in ricerca e sviluppo è salita al 2,68% del PIL nel 2024 e la Cina guida i depositi brevettuali mondiali.
A questo si aggiunge un’accelerazione sulla transizione energetica, con nuova capacità rinnovabile (solare ed eolica) installata su scala senza precedenti.
Questo risultato non nasce da un’economia di mercato “libera”, né da una pianificazione totale in stile sovietico. Nasce da un’architettura ibrida. Dalla fine degli anni ’70 la Cina ha trasformato un’economia pianificata rigida in una forma di “capitalismo amministrato”: lo Stato definisce le traiettorie di sviluppo e usa il mercato per percorrerle più velocemente.
Deng Xiaoping aveva già chiarito il principio nel 1984: “La pianificazione e il mercato non sono la linea di demarcazione tra socialismo e capitalismo; la pianificazione non equivale al socialismo, il mercato non equivale al capitalismo”.
Tre decenni dopo, Xi Jinping ha formalizzato questo equilibrio al Terzo Plenum del 2013: “Il mercato deve svolgere un ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse, e il governo deve svolgere meglio il proprio ruolo”. In altri termini: non è lo Stato contro il mercato, è lo Stato che utilizza il mercato come strumento operativo della strategia nazionale.
La macchina politica è la macchina economica
Sul piano istituzionale ciò si traduce in un meccanismo multilivello. Il centro politico – attraverso i Piani Quinquennali e strategie pluriennali mirate come il “Made in China 2025” – indica le priorità tecnologiche, industriali e di sicurezza economica.
Ministeri, organismi che supervisionano le imprese di Stato, governi provinciali e fondi pubblici di investimento trasformano quelle priorità in credito agevolato, autorizzazioni, infrastrutture materiali, standard tecnici e domanda pubblica.
Le province e le città competono tra loro per attrarre imprese e filiere, mentre le imprese pubbliche rivaleggiano con quelle private per commesse, standard e quote di mercato.
Il risultato è un sistema in cui gli obiettivi sono decisi politicamente, ma la selezione degli attori che sopravvivono e crescono avviene attraverso una concorrenza reale.
Competizione alla cinese
Il cuore di questo meccanismo è spesso descritto come “tournament competition”, cioè una competizione a torneo.
Nella fase iniziale lo Stato apre deliberatamente un settore strategico a un numero molto elevato di imprese, non impedendo l’ingresso ma anzi sostenendolo con credito, accesso ai terreni, partnership con enti pubblici, sbocchi garantiti nella domanda pubblica locale.
È il caso del programma “Ten Cities, Thousand Vehicles”, lanciato nel 2009, che ha usato il mercato urbano – autobus, taxi, logistica – come laboratorio per far crescere i veicoli elettrici (NEV).
In quella fase, tutti gli operatori sono stimolati ad entrare nel mercato. Centinaia di marchi si sono affermati dopo il 2009.
Dentro o fuori
Nella seconda fase, lo Stato riduce gradualmente i sussidi diretti, introduce meccanismi regolatori, alza gli standard tecnici.
In questo passaggio, chi riesce davvero a produrre in scala, abbassare i costi, garantire qualità, esportare e brevettare sopravvive; chi non regge il ritmo viene spinto al consolidamento, alla fusione o all’uscita.
Nel caso dei NEV, tra il 2018 e il 2025 molte imprese elettriche cinesi sono scomparse o sono state assorbite: oggi si stima che restino circa 129 marchi EV/PHEV attivi e le analisi di settore indicano che a lungo termine potrebbero sopravviverne una quindicina, cioè l’ordine di grandezza del 10–15%.
Gli attori più noti (i “vincitori del torneo”) sono BYD, primo produttore di veicoli elettrici per volumi, e CATL, che ha raggiunto una quota vicina al 38% del mercato globale delle batterie nel 2024.
Il messaggio è che la scala produttiva e la velocità di apprendimento non sono casuali: sono un esito programmato.
Questa stessa logica si sta ora estendendo alle piccole e medie imprese innovative. Se in passato l’attenzione politica era concentrata sui grandi gruppi nazionali, oggi le PMI high-tech vengono considerate tasselli critici per la sovranità tecnologica: componenti di nicchia, materiali avanzati, elettronica specializzata, alternative domestiche a ciò che prima veniva importato.
A livello locale, provinciale e centrale esiste un sistema di classificazione e sostegno che seleziona le PMI “di qualità strategica” e le fa crescere con accesso preferenziale a capitale pubblico-privato, appalti, zone industriali dedicate, standard tecnici nazionali. È una forma di accelerazione industriale dall’alto, ma giocata attraverso il basso.
I punti di forza
I punti di forza di questo modello sono evidenti.
- Primo: velocità e scala. L’apertura iniziale a molti concorrenti, seguita da una rapida selezione, permette di comprimere i costi unitari, aumentare la capacità produttiva e diffondere rapidamente una tecnologia (come è accaduto con l’elettrico e il solare).
- Secondo: allineamento strategico. Il profitto privato non viene lasciato libero di muoversi ovunque, ma viene incanalato verso obiettivi pubblici considerati “missioni nazionali”: energie pulite, autonomia tecnologica, filiere critiche.
- Terzo: ridondanza gestita. Finché tante imprese sono autorizzate a sperimentare in parallelo, la probabilità che almeno alcune trovino un modello vincente aumenta, riducendo il rischio politico di puntare tutto su un solo campione troppo presto.
Costi e fragilità di un modello competitivo
Ma il modello ha anche costi e fragilità. La prima è la sovracapacità: se lo Stato non ritira gli incentivi in tempo, la produzione continua a crescere anche quando il mercato interno è saturo e i prezzi scendono in modo aggressivo. Questo spinge le imprese a riversare l’eccesso di offerta all’estero, alimentando tensioni commerciali globali. Il dibattito internazionale sulle esportazioni cinesi di veicoli elettrici e pannelli fotovoltaici nasce anche da qui. Secondo: il rischio finanziario.
Il credito agevolato e i fondi pubblici possono tenere in vita aziende che non sono più competitive (“campioni zombie”), con accumulo di debito e rischio di bolle industriali locali. Terzo: la pressione sul costo può comprimere l’investimento nell’innovazione di frontiera a più alto rischio tecnologico e più lungo ritorno economico, privilegiando il miglioramento incrementale e la scalabilità rapida rispetto alla ricerca radicale. Quarto: la concorrenza tra province, pur utile per l’efficienza, può produrre duplicazioni, sovrapposizioni di progetti e talvolta investimenti infrastrutturali ridondanti.
In definitiva, il “socialismo con caratteristiche cinesi” è l’idea che lo Stato rimanga il centro di comando strategico, ma che usi il mercato come motore operativo di selezione e accelerazione industriale.
Giovanni Arrighi (2017) lo formulava così: “si possono aggiungere tutti i capitalisti che si desidera a un’economia di mercato, ma se lo Stato non è subordinato ai loro interessi di classe, l’economia di mercato rimane non capitalistica”.
La Cina, oggi, è l’esperimento più avanzato di questa impostazione: una potenza manifatturiera e tecnologica che tenta di governare l’innovazione non solo con la pianificazione, e non solo con il mercato, ma con una combinazione disciplinata di entrambi.