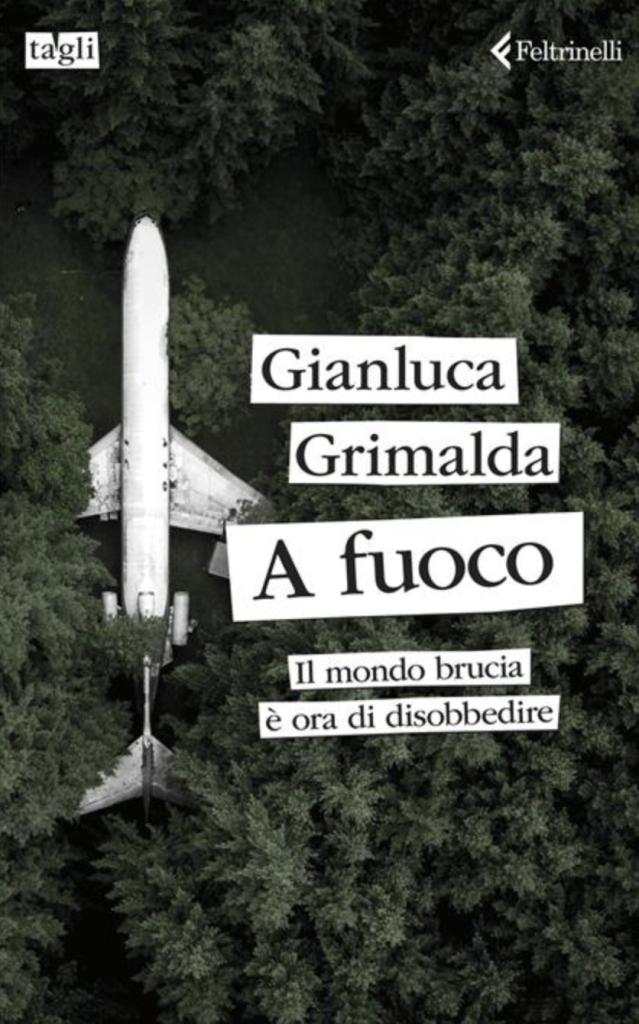28.000 chilometri percorsi in nave, treno, pullman, camion, taxi, per 650 ore di viaggio effettivo in 72 giorni. E’ il viaggio di Gianluca Grimalda, ricercatore in scienze sociali e attivista climatico, primo lavoratore dipendente licenziato per il suo rifiuto di prendere un aereo. Un’esperienza raccontata nel suo libro A fuoco. Il mondo brucia è ora di disobbedire di cui per gentile concessione dell’Editore e dell’autore qui pubblichiamo un estratto.
Il libro nasce da un viaggio di ricerca nell’isola di Bougainville, nell’arcipelago delle Salomone, dove Grimalda ha indagato il legame tra coesione sociale, disuguaglianze globali e cambiamento climatico. L’estratto è ambientato nel villaggio di Talmuts, situato nell’Arcipelago di Saposa, al largo della costa nord-occidentale di Bougainville. Qui, l’autore incontra comunità che vivono gli effetti più drammatici della crisi climatica: la perdita di terra abitabile, l’avanzare del mare, la salinizzazione dei suoli, lo sradicamento culturale.
“Vede doctor Grimalda, la mia casa era lì, proprio lì dove la canoa di mio nipote sta passando ora,” mi dice un uomo magrissimo dal volto rugoso che sembra scavato in una quercia, mentre indica un punto a circa venti metri dalla costa. “Tutte le famiglie che vivevano lì sono state costrette a spostarsi lontano dalla costa. Siamo riusciti a recuperare molti dei materiali con cui avevamo costruito le capanne, eccetto i piloni di sostegno in legno che sono tutti marciti.
Ma il problema è che non possiamo arretrare all’infinito; alla fine ci viene a mancare la terra da coltivazione e dove abitare. Già le mareggiate rendono le terre più saline e quindi sempre meno fertili.” “Lo so bene. Tutte le comunità costiere che ho visitato qui a Bougainville hanno avuto la necessità di emigrare 81 verso l’interno, a volte andando a stare su altopiani anche a cento metri sul livello del mare.”
La resistenza autonoma
Io non mi fido degli uomini bianchi,” inveisce Shirley. “Finalmente ho capito che sono le industrie del fossile e le macchine che costruite voi white men che fanno sì che le temperature aumentino e, come diciamo in tok pisin, che ‘il mare mangi la spiaggia’, cioè che il livello dei mari si alzi. Gli uomini bianchi avevano promesso che si sarebbero fatti carico del trasferimento delle popolazioni che vivono nelle Isole Carteret, quando sin dal 2009 l’innalzamento del livello dei mari le costringeva a migrare per la scarsità di cibo e per le malattie.
Ma queste promesse non sono mai state mantenute cosicché gli abitanti delle Carteret fondarono un’associazione che si chiama Tulele Peisa, cioè ‘solchiamo le onde da soli’.10 Hanno trovato aiuto da qualche Ong europea, dall’Onu e dalla diocesi di Bougainville e hanno quanto meno incominciato a trasferire alcune famiglie.” “E quante persone sono state costrette a lasciare le loro terre per effetto dell’aumento delle temperature?” mi chiede un lapun che l’altro giorno mi aveva mostrato un salice secolare, con lo sguardo preoccupato.
“Tantissime. Secondo le recenti statistiche pubblicate dall’‘Internal Displacement Monitoring Centre’, dal 2008 oltre 376 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a emigrare a causa di inondazioni, tempeste, siccità o terremoti, con un record di 32,6 milioni solo nel 2022.”
“E quante saranno, o saremo, in futuro?”
“È difficile dirlo, perché il fattore umano si mischia a quello fisico. Il numero di persone che abitano in zone la cui elevazione è al di sotto del livello dell’alta marea è stimabile, per il 2100, in circa 190 milioni in condizioni di basse emissioni di carbonio e 630 milioni in caso di alte emissioni. Potrebbero già essere 340 milioni nel 2050.12 82 Teoricamente ci aspetteremmo che persone in queste condizioni siano costrette a emigrare.
Se contiamo le persone che vivono in zone costiere a rischio di inondazioni, al momento sono 600 milioni e, sulla base degli attuali ritmi di incremento demografico, potrebbero aumentare a un miliardo alla fine del secolo.” Avverto un silenzio profondo negli astanti. Non si aspettavano che la loro sorte fosse comune a così tante altre persone. Shirley prende la parola interpretando il sentire di tutta la comunità. “Sarà difficilissimo per noi lasciare questa isola, che porta ancora il nome del capostipite del clan che per primo qui si insediò, Talmuts.
E so già che alcune persone decideranno di morire qui piuttosto che andare a vivere in una terra che non sentono come loro madre.” “Infatti, gli scienziati hanno forse più difficoltà a prevedere il fattore umano nella scelta di migrare che quello climatico. Molte persone sembrano preferire sopportare disagi e rischi che molti ricercatori, specialmente occidentali, considererebbero inaccettabili. Alcune comunità nelle Filippine, ad esempio, hanno scelto di continuare a vivere sulle loro isole, anche se il territorio è completamente sommerso dalle alte maree fino a 40 cm, e anche se il trasferimento su terraferma, distante solo 6 km, sarebbe pagato dal governo.”
Consigli di lettura
Un racconto di viaggio.
Un’analisi del cambiamento climatico nel mondo.
Un invito all’azione collettiva.
«Provate a pensare fuori dagli schemi e chiedetevi, nella vostra sfera personale, cosa potete fare per cercare di limitare le vostre emissioni. Cercate di rendere lo straordinario ordinario.»
Questo libro racconta il perché della sua scelta, coerente con la sua decennale esperienza di “viaggiatore lento” orientata a ridurre le proprie emissioni di CO². La sua vicenda lavorativa e affettiva si intreccia al racconto del viaggio di 28.000 chilometri – dall’isola di Bougainville, nelle Isole Salomone, alla Germania – percorsi in nave, treno, pullman, camion, taxi, per 650 ore di viaggio effettivo in 72 giorni. Il viaggio lento offre la possibilità di mettere così “a fuoco” gli abitanti della “periferia globale” e di ascoltare le perdite da loro già sofferte in relazione al cambiamento climatico in corso, le loro paure, speranze, e le loro forme di adattamento.
In queste pagine Grimalda mette in atto la possibilità di cambiamento sociale offerta dalla disobbedienza civile e ci costringe a guardare in faccia la dissonanza che attraversa le nostre vite: sapere ciò che andrebbe fatto, ma non farlo. “A fuoco” ci interroga su quale sia il confine tra responsabilità individuale e collettiva, ma è anche un invito: a cambiare direzione e superare il prima possibile la nostra dipendenza tossica dai combustibili fossili.