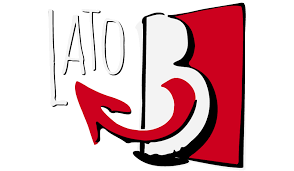Generazioni e lavoro: come TikTok racconta il cambiamento
Se passate un po’ di tempo su TikTok vi sarete sicuramente imbattuti in un certo tipo di video: “Come lavorano le generazioni a confronto?”.
Il copione è sempre lo stesso. Il boomer si sveglia presto, arriva in ufficio per primo, tratta male i sottoposti e torna a casa soddisfatto, pronto a ricominciare il giorno dopo. Il lavoratore della Gen X è più rilassato, ma comunque sicuro di sé e orgoglioso del proprio ruolo. Il millennial, invece, è sull’orlo di una crisi di nervi: ansioso, frustrato, sempre pronto a scusarsi con tutti e pieno di sensi di colpa. Poi c’è la Gen Z, che sembra aver perso del tutto interesse: arriva tardi, minimizza le sue negligenze, scrolla sullo smartphone, aspetta solo l’ora di uscita.
Questi video, nati per divertire, raccontano in realtà molto del nostro tempo. Mostrano un cambiamento profondo: il lavoro non è più il centro della vita, ma un ingombro necessario, un frammento tra gli altri. Dove un tempo si cercava nel lavoro un senso, oggi si cerca solo di sopravvivere al suo peso e spesso è percepito come un fastidio, un passaggio obbligato per poter permettersi qualcos’altro: tempo libero, vacanze, passioni, o semplicemente il diritto di staccare.
Quiet quitting e il declino del mito del lavoro come autorealizzazione
Questo mutamento di prospettiva racconta molto di come oggi si sia incrinato il mito del lavoro come autorealizzazione. Per decenni lavorare non è stato solo un mezzo, ma un fine in sé: l’identità, il valore personale, la rispettabilità sociale passavano tutti di lì. “Che lavoro fai?” era una domanda che sottintendeva, implicitamente, “Chi sei?”.
La verità è che non sogniamo più il lavoro — e forse, finalmente, lo abbiamo smascherato.
Abbiamo capito che non ci salva, non ci garantisce sicurezza e raramente ci restituisce il tempo che gli offriamo.
Il lavoro contemporaneo, soprattutto per chi è nato dopo gli anni Novanta, è diventato un territorio ambiguo: onnipresente ma vuoto di senso. Si lavora sempre — anche quando non si è “al lavoro” — rispondendo a messaggi, aggiornando cv, coltivando competenze. Ma allo stesso tempo si fatica a crederci davvero. Si fa per necessità, non per desiderio. È una recita di efficienza che non promette più niente in cambio.
Nessuno, infatti, crede più alla promessa del “fatica, studia, impegnati e vedrai che riuscirai ad emergere” o anche solo a cambiare la tua condizione sociale. Il mito è caduto, si cercano altre strade, si spera di “svoltare” con altri mezzi, soprattutto grazie ad Internet.
“Non sognare il lavoro” però non è solo una forma di apatia, ma anche una forma di resistenza.
Diritti, collettività e nuove forme di resistenza al lavoro precario
Al Lato B Milano – circolo sociale, culturale e politico di viale Pasubio – è aperto, ormai da 5 anni, uno sportello di prima consulenza legale gratuita a cui è possibile rivolgersi per comprendere meglio il proprio contratto, per chiedere informazioni, per risolvere un problema o un contenzioso col datore o con l’azienda.
Da sempre molto partecipato, è affiancato anche da un corso di alfabetizzazione ai diritti del lavoro che, in tutte le sue edizioni, ha visto avvicendarsi sempre più un’utenza giovane e, spesso, precaria.
Le persone vogliono conoscere i propri diritti per resistere, per non farsi divorare dal lavoro, per poter ottenere ciò che gli spetta e smettere di accettare condizioni che promettono visibilità ed esperienza, ma che non servono per ciò per cui si lavora: vivere una vita degna.
Non accettare di passare il proprio tempo a lavorare, richiedere la settimana corta, rivendicare il proprio tempo libero per sé, senza dover rispondere alle mail o ai messaggi h24, smettere di credere che “siamo una famiglia, ognuno deve fare qualche sacrificio per gli altri e per l’azienda”, sono passi fondamentali per emanciparsi dal ricatto del salario.
E se ancora la generazione dei millennials, come ci insegna Tiktok, è prigioniera di questo ricatto, pur sapendo che non porterà realmente a potersi permettere una famiglia, un tetto sopra la testa, un futuro solido, sono proprio i giovanissimi a ribaltare il paradigma finora vigente.
Capire che bisogna lavorare per vivere e non vivere per lavorare è il primo passo per poter uscire dalla precarietà, dalla foresta di contratti e stage sottopagati, dalla promessa che se oggi ti fai sfruttare forse, un domani, potrai vivere la tua vita.
Tuttavia, a questo rifiuto manca ancora un tassello fondamentale: la collettività. Solo insieme possiamo costruire un nuovo mondo del lavoro, che non si fondi sul profitto e sullo sfruttamento del più forte sul più debole; un mondo in cui il lavoro non sia una prigione necessaria, ma un mezzo di emancipazione e di dignità, dentro e fuori da esso. Un lavoro a misura d’essere umano, che permetta di lavorare meno per lavorare tutti, rispettando i tempi e i bisogni di ciascuno.
Dobbiamo smettere di credere che questo sia l’unico mondo possibile, l’unico lavoro possibile. Dobbiamo tornare a immaginare — e a lottare — per qualcosa di diverso. Perché se ci muoviamo insieme, se insieme rifiutiamo la falsa promessa che per secoli ci ha spinti a sfruttarci a vicenda, allora il cambiamento diventa possibile.
Non è il singolo a poter rovesciare un sistema bugiardo, ma la collettività che smette di credergli. Quando il “non ci sto” diventa plurale, il lavoro può tornare a essere uno strumento per vivere, non ciò che ci divora la vita.