La guerra in casa (Einaudi, 1998), è l’esordio di Luca Rastello che racconta la guerra nella ex-Jugoslavia attraverso le voci dei profughi e dei volontari in Italia, e con uno stile che fonde la cronaca con la testimonianza intima. Nel numero di PUBBLICO dedicato all’anniversario del genocidio di Srebrenica, pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell’editore e degli eredi dell’autore.
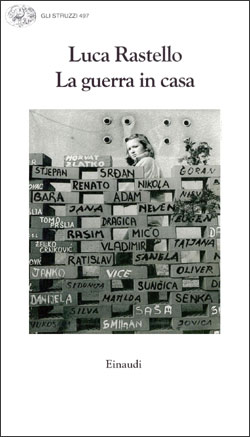
«Il massacro ha i suoi orari. Alle sei meno un quarto di sera finisce. (Irfan non lo sa, ma il massacro ha anche la sua estetica, e le sue spiritosaggini: a Bijeljina un giorno arrivarono con una macchina su cui avevano montato un’insegna luminosa che diceva: “massacro”. E il massacro ci fu). Dopo il lavoro, i serbi, affaticati, cantavano: “Cantavano i loro canti, pieni di Serbia ti amiamo”, pieni di S maiuscole. La gente era terrorizzata: “Li vedevi arrendersi e consegnarsi anche se sapevano benissimo che quegli altri li ammazzavano senza guardarli in faccia”.»
«Su ogni strada, su ogni prato restarono solo i cadaveri. E la puzza. “Tagliavano i ventri delle donne. Sentivi le cannonate dalla parte di Vrhpolje. Per il resto sentivi solo piangere”: era la gente che capiva, incominciava a capire che lì non si poteva più vivere. In undici ore avevano cancellato migliaia di persone. “Aveva ragione Karadzić: ‘Se ci sarà la guerra, uno dei tre popoli scomparirà’. Eravamo noi. L’hanno fatto nel ’92, ma era tutto preparato fin da prima che io nascessi.”»
«Così pensa Irfan, il vendicatore, in un pomeriggio d’estate torinese. Riordina le immagini di un album immaginario in cui è ritratta la tragedia che agli occhi del mondo si è concentrata in quei sette giorni del luglio ’95, quando la cittadina di Srebrenica cadde sotto il maglio del generale Mladić e novemila persone scomparvero nel nulla. Ma Irfan non accetta che tutto si riassuma in quell’ultima settimana. Irfan senza diritti, il giustiziere, vuole dar ragione al tempo, vorrebbe fermare la pellicola, farti vedere tutti i fotogrammi come se fossero stampe di un album. Il suo tempo, tre anni di assedio e follia. Lui ci vivrà per sempre, avanti e indietro, su e giù, lungo la spina di quei tre anni.»
«Adesso, in quel maggio del ’92, i vicini di casa erano diventati sinceri, dicevano: “Sapete? Siete più simpatici da morti”. Irfan e i suoi decisero di raggiungere Srebrenica, attraverso i boschi, tutti insieme, verso la città di Naser Orić, quello che ai serbi aveva resistito. Ma era una strada senza fine, ventitré ore di cammino senza soste, senz’acqua. Irfan ricorda i neonati che morivano durante il tragitto, i vecchi che si fermavano per strada: “All’inizio li seppellivamo, dove capitava. Dopo li lasciavamo dov’erano, senza far niente.”»
«Il primo villaggio della zona di Srebrenica che incontrarono si chiamava Lokva (“pozzanghera”): “La gente di Lokva non credeva a quello che raccontavamo. Avevano sentito sparare, sì, ma anche a Lokva quegli altri erano andati in giro a dire: ‘Non avete nulla da temere…’”»
«La gente di Lokva non credeva a quello che raccontavamo. Avevano sentito sparare, sì, ma anche a Lokva quegli altri erano andati in giro a dire: “Non avete nulla da temere, non vi succederà nulla”.»
«Il giorno dopo, a Lokva, arrivarono anche quelli scappati dalla città. Dicevano che Srebrenica era occupata. Vissero qualche giorno nei villaggi, dove gli abitanti aiutavano soltanto i vecchi e i bambini piccoli. Per gli adulti non c’era nulla: “Si viveva di funghi, acqua, frutti di bosco. Anche foglie”. L’artiglieria continuava a martellare, e intanto loro, i bosniaci nei boschi, anche dopo tutto quel sangue, continuavano con il loro chiodo fisso: “Venti giorni, trenta, poi tutto sarà di nuovo come prima”.»
«Il mese di maggio finì lì, nei boschi. Ma c’era Orić con loro, c’era la dinamite della miniera. Un giorno, fra maggio e giugno, approfittarono delle feste che impazzavano nei villaggi serbi, dell’alcol, della confusione, dell’arroganza di chi pensava di aver imposto il terrore: “C’è confusione, qualcuno spara, qualche morto”. I dannati dei boschi si buttarono su Srebrenica, entrarono. Dicono che è stato un massacro, dicono di gente uccisa per strada, di una fossa comune per quei corpi serbi su cui i generali avrebbero costruito giorno dopo giorno la voglia di vendetta degli assedianti.»
«I tedeschi hanno un nome per questo tipo di paesi: Strassendorf, quelle doppie file di case ai lati di una strada di traffico importante. Srebrenica è uno Strassendorf da quattromila abitanti. Ci entrano in tanti, 35-40.000. Troppi: vengono anche da Žepa, Goražde, Vlasenica, Višegrad, tutti posti dove i serbi stanno facendo la loro pulizia.»
«Srebrenica è lunga quattro chilometri, larga quattrocentocinquanta metri. Da quel budello non si esce più. Firmato Boutros Ghali. Firmato Lord Owen, Cyrus Vance, Thorwald Stoltenberg. Firmato François Mitterrand, John Major, forse Bill Clinton. Firmato Aljia Izetbegović, anche.»
Luca Rastello, La guerra in casa
© 1998 e 2020 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino



