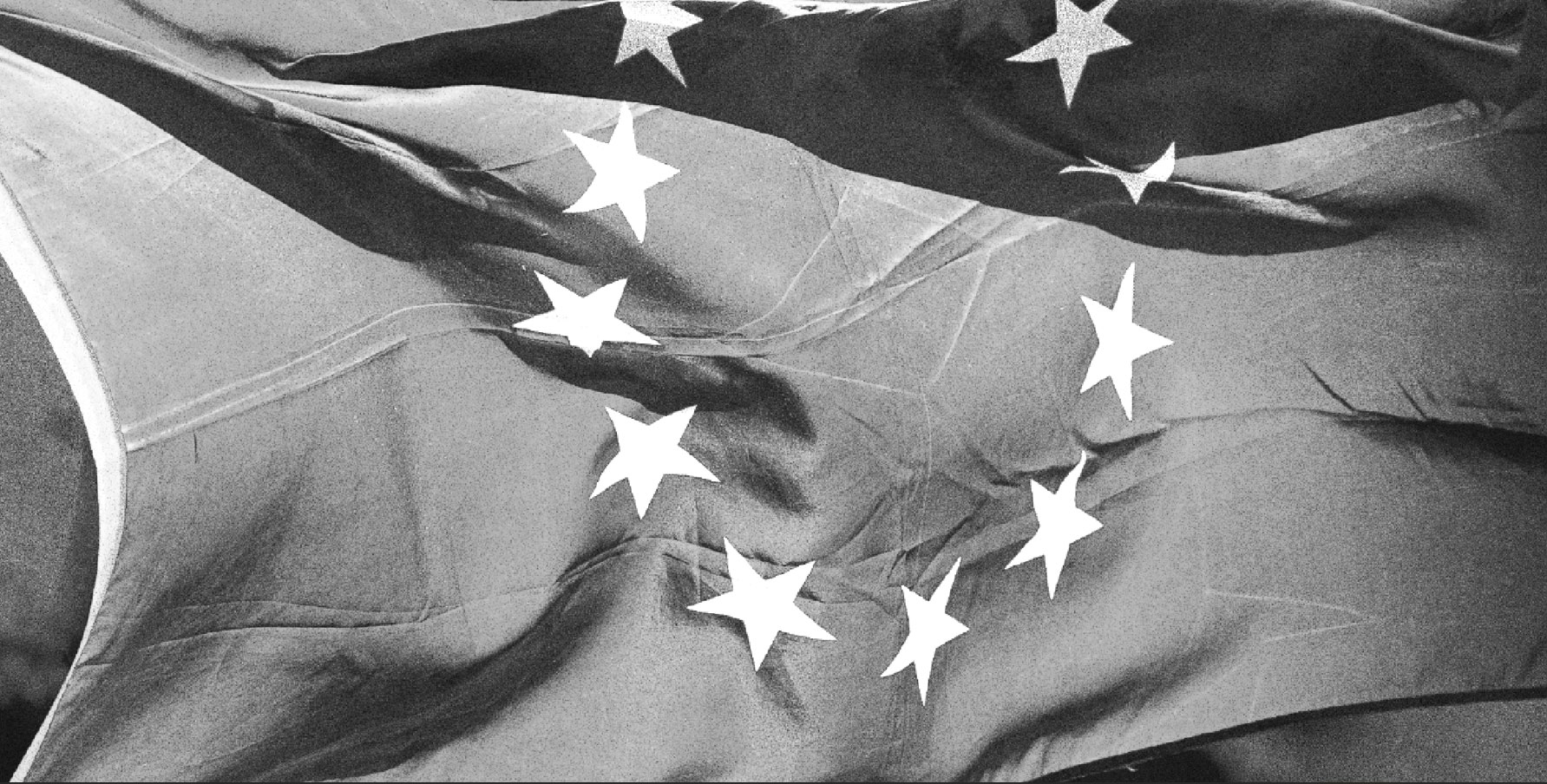Il diffondersi dell’epidemia di coronavirus ha spinto governi, istituzioni pubbliche in genere e attori privati a prendere severe misure di restrizione alla libertà di movimento delle persone. Che l’emergenza sia reale o meno, non rileva ai fini di questo breve articolo; anzi, è interessante il paragone con la presunta “emergenza migratoria” per mettere in evidenza alcuni punti. Anche in quel caso, vennero (e vengono, ogni qual volta lo si ritiene opportuno per i più vari fini) prese misure di restrizione al movimento delle persone. Naturalmente, rafforzando le barriere di ingresso ai Paesi dell’Unione Europea; ma soprattutto, con l’annullamento di fatto della libertà di movimento all’interno dell’area Schengen. Assistiamo invero in queste ore a un plastico raffronto tra i due casi: mentre gli italiani vengono bloccati a bordo di aerei atterrati in lussureggianti atolli tropicali, o turisti di ogni angolo del pianeta si trovano imprigionati a Milano perché le compagnie hanno deciso di chiudere le rotte – evidentemente perché non più profittevoli –, arrivano le violente (e disgustose) immagini della guardia costiera greca che tenta di affondare i gommoni dei migranti in fuga dalla guerra siriana. Perché allora nel caso del coronavirus in molti si stanno chiedendo se ci si trovi di fronte a una messa in discussione della globalizzazione, mentre le frontiere chiuse ai profughi non hanno mai suscitato tale domanda? Di che globalizzazione stiamo parlando?

Credo che la risposta stia nell’identificazione, promossa dalla narrazione neoliberale (qui un emblematico esempio di queste ore) e diventata senso comune, tra globalizzazione e benessere economico. E, allo stesso tempo, a una correlata imprecisa interpretazione di cosa la globalizzazione effettivamente sia. Il coronavirus ha e avrà effetti sull’economia (molti gli istituti che in questo momento stanno cercando di quantificarli: esempio ne è il lavoro dell’OCSE); il coronavirus non ha invece il potere di mutare lo stadio di sviluppo del sistema capitalistico mondiale, per semplicità chiamato “globalizzazione”, e riassumibile in tre libertà fondamentali: di movimento di capitali, merci e persone. Come argomentato più diffusamente in altre sedi, la “globalizzazione reale” si caratterizza soprattutto per la completa libertà di movimento dei capitali – responsabile, tra le altre cose, della nostra dipendenza dalle fabbriche cinesi, spiegata nelle prossime righe. Gli altri due pilastri, al contrario, sono solo molto parzialmente realizzati, in particolare la libertà di movimento delle persone. Quindi, il coronavirus, così come il blocco di centinaia di migliaia di migranti alle frontiere dei Paesi industrializzati (milioni, anno dopo anno), non mette la globalizzazione in pericolo: la differenza tra i due casi sta solo nelle diverse conseguenze che questo ha sull’economia dei Paesi industrializzati stessi, come ricordato in questo approfondimento sull’emergenza sanitaria di questi giorni. L’articolo è emblematicamente intitolato “può l’UE permettersi la chiusura dei confini?”, e alla domanda si risponde che poteva sì permetterselo nel 2015 di fronte ai migranti, non può permetterselo ora di fronte al virus.

Ci si rende allora facilmente conto della natura fallace del discorso sulla globalizzazione in pericolo. La globalizzazione non torna indietro perché si alza qualche (momentanea) ulteriore barriera che si aggiunge ai molti muri che già sono presenti in tutto il mondo per bloccare il libero movimento delle persone. La globalizzazione non è in pericolo, nonostante i pesanti effetti economici che il coronavirus avrà su molti Paesi del mondo. Certo, la globalizzazione è lo strumento di propagazione sia del virus che dei suoi deleteri effetti, o meglio di accelerazione di tale propagazione, perché sempre nella storia dell’uomo le epidemie si sono diffuse da un angolo all’altro del mondo. Ma analizzando come avviene questa accelerazione, e come si diffondono i gravi effetti economici, si capisce che le radici del sistema economico globale sono profonde e coinvolgono principalmente altri elementi – in particolare produttivi – che ben più del turismo definiscono il mondo (e il modo) in cui viviamo.
Infatti, l’epidemia in corso, rispetto alla precedente epidemia comparabile, quella della SARS del 2003, non solo sta avendo conseguenze più gravi sulla Cina, nella quale il peso dei servizi sul totale dell’economia è cresciuto del 40% nel periodo tra le due epidemie – e quella dei servizi è la componente più colpita da questo tipo di evenienze; ma, dato il ruolo della Cina nella configurazione capitalistica globale – la globalizzazione – avrà conseguenze ben più pesanti anche sul resto dei Paesi. E questo, naturalmente, a prescindere dagli effetti diretti del virus in ogni singolo Paese. Si tratta di un aspetto messo chiaramente in luce nella presentazione del report già citato che l’OCSE ha fatto il 2 marzo: in particolare, occorre osservare il grafico che indica il ruolo della Cina in alcune delle più importanti catene globali di valore (global value chains): quella dell’elettronica e quella del settore automobilistico. In queste ultime, la Cina è responsabile per la produzione, rispettivamente, del 27% e del 13% del valore aggiunto dei beni intermedi prodotti. Perché si tratta di un dato importante? Un aspetto fondamentale della globalizzazione, spinto dagli ingenti flussi di investimenti di capitale all’estero, è proprio l’integrazione produttiva in catene globali di valore, per cui è ben più significativo concentrarsi sui beni intermedi piuttosto che sugli scambi commerciali (questi ultimi, per altro, già in calo negli ultimi anni). Questi dati indicano quindi che se si fermano le fabbriche in Cina (e Hubei, epicentro del coronavirus, è uno snodo fondamentale della produzione industriale cinese e, appunto, mondiale), si fermano anche nel resto del mondo. In che misura? Ad esempio, il 24% della produzione di elettronica degli Stati Uniti è dipendente dai beni intermedi cinesi, il 14% di quella dell’Unione Europea, l’8% di quella giapponese.
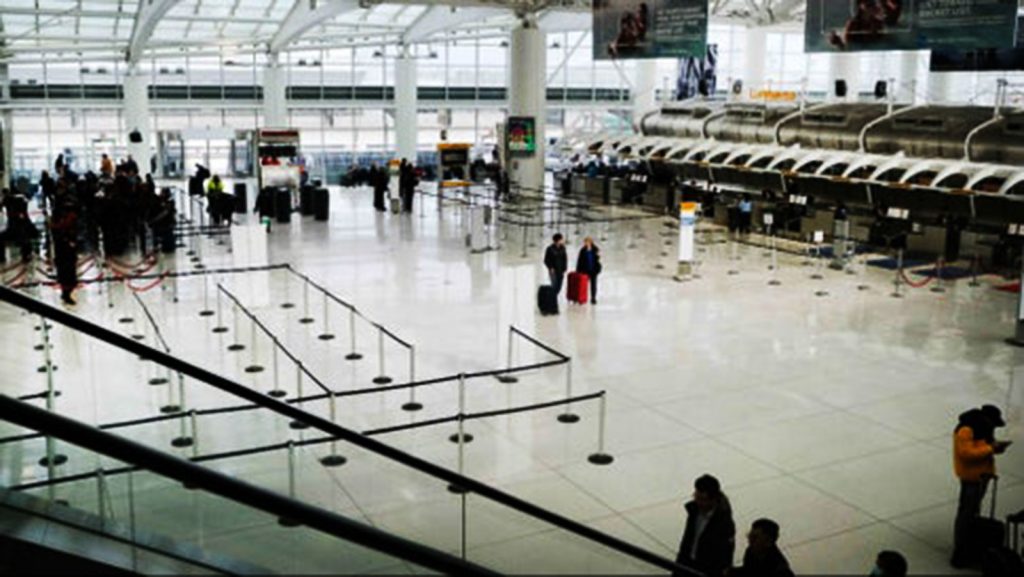
Se l’economia funzionasse come postulato dall’ideologia dominante in accademia e, spesso, nel sistema mediatico, sarebbe (stato) sufficiente diversificare la provenienza di suddetti beni intermedi e ricollocare i nodi delle catene di valore in altri Paesi del mondo. Oppure, se funzionasse come vorrebbe un certo nazionalismo d’accatto, purtroppo ben affermato in molti Paesi del mondo, sarebbe sufficiente riportare la produzione dentro i confini nazionali, dalla sera alla mattina. Allora, in entrambi i casi – giornalisticamente parlando, nella versione liberista e in quella sovranista – la globalizzazione potrebbe effettivamente essere in pericolo, o comunque soggetta a una profonda ridefinizione. L’economia tuttavia, come ben sa chi ha fatto piani pluridecennali di investimenti in Cina, per una portata economica complessiva tale da disegnare i contorni delle catene internazionali di valore, non funziona così, e la globalizzazione non verrà imbrigliata, ridimensionata, né tornerà indietro nel giro di pochi giorni o mesi perché le fabbriche cinesi lavorano momentaneamente a ritmi ridotti; ancor meno, perché i flussi turistici sono improvvisamente caduti a picco. Il vero elemento qualificante della globalizzazione, la libertà di movimento dei capitali, non viene intaccato dalle misure straordinarie di contenimento del contagio, come esemplificato dalla deteriore innovazione del CoronaToken. Il sito del neonato strumento finanziario descrive esplicitamente la moneta virtuale come un mezzo per speculare sulle morti provocate dalla malattia: maggiore il numero di contagi, maggiore la ricchezza accumulata dai detentori.
Potremo considerare questa globalizzazione in pericolo solo quando verranno introdotte forti misure di limitazione al movimento di capitali. E, da molti punti di vista, non sarebbe una cattiva notizia: non a caso, “liberisti” e “sovranisti”, pur da prospettive opposte, sono alleati nell’agitare lo spettro della fine della globalizzazione identificando sempre il bersaglio sbagliato. Una volta i migranti, un’altra il virus; altre volte è stata la concorrenza sleale della Cina, l’ingerenza russa… Purché mai si parli della incontrollata libera circolazione di capitali.