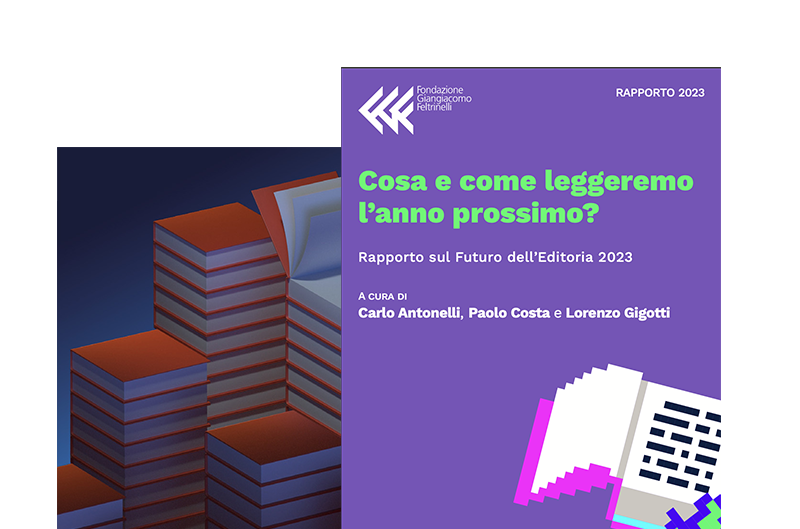


Economia, Politica, Storia, Immaginari, le prossime iniziative pubbliche di Fondazione Feltrinelli
Economia, Politica, Storia, Immaginari, le prossime iniziative pubbliche di Fondazione Feltrinelli
Articoli, inchieste e speciali editoriali



ebook, libri, fonti d’archivio
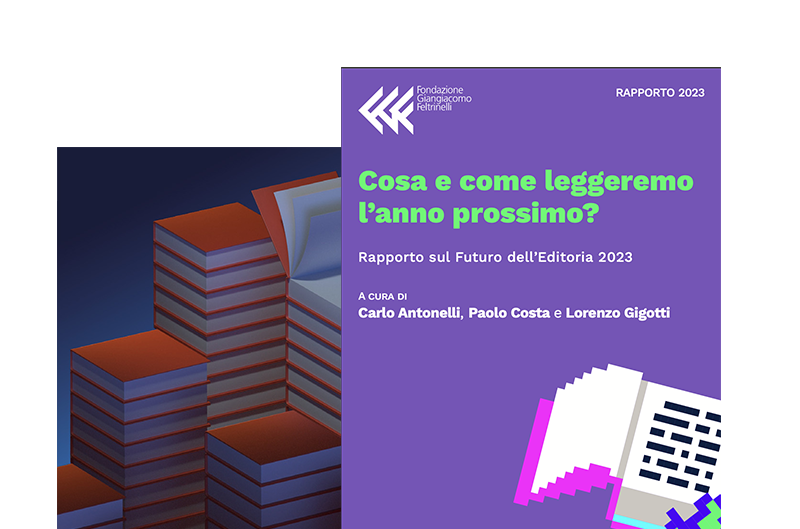
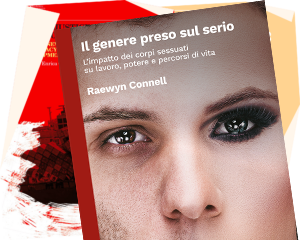
Come nascono gli stereotipi di genere? La risposta della sociologa Raewyn Connell
Scopri di più
Le Mostre Digitali: un viaggio tra le fonti d'archivio di Fondazione Feltrinelli
Scopri di più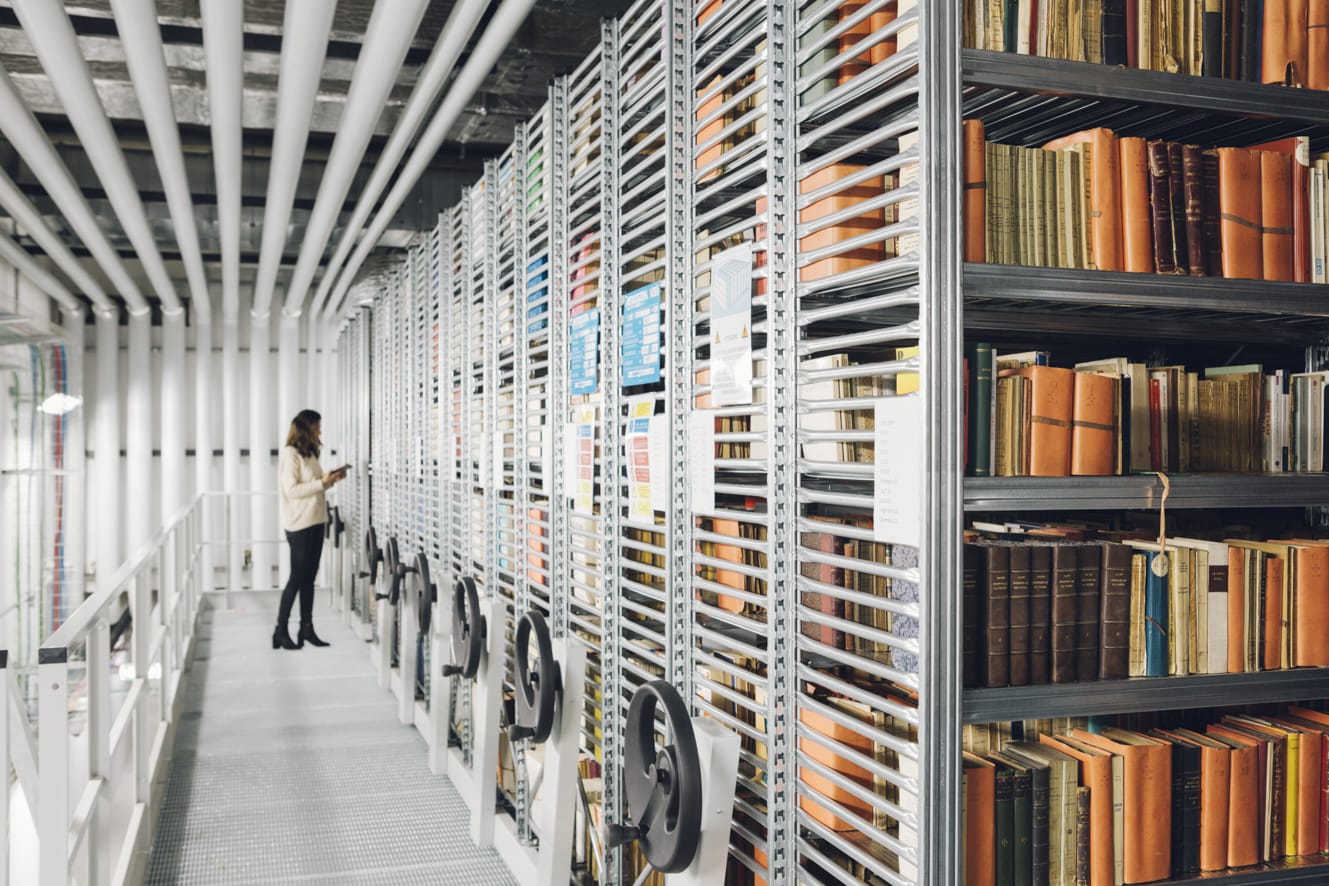
Consulta gli inventari degli archivi e il catalogo della biblioteca.
Consulta l’Archivio Esplora la Biblioteca
Un ambiente tranquillo e accogliente per studiare e lavorare.
Scopri gli orari Prenota il tuo posto